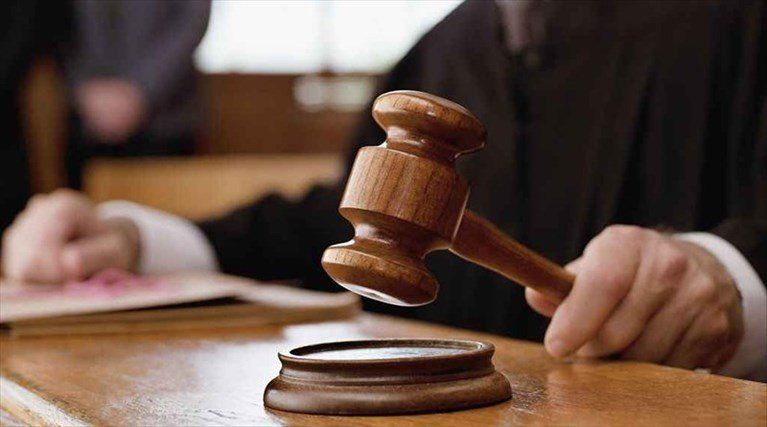“Se talvolta inclinassi la bilancia della giustizia,
fa' che ciò avvenga non sotto il peso dei doni,
ma per un impulso di misericordia”
(Miguel de Cervantes)
"LA TUTELA AMMINISTRATIVA: DAL SINDACATO INCIDENTALE DEL GIUDICE PENALE ALLA POSSIBILE ESTENSIONE DEL SINDACATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO"
Convegno in presenza a Bergamo:
Venerdì 15 novembre 2024 ore 15.00
Cerca nel sito
*Inserire una sola parola chiave per trovare articoli sulla tematica di interesse
L’angolo dell’attualità

Quando cinque anni fa uno sparuto gruppo di magistrati tentò la strada dell’indipendenza dalle correnti associative dominanti nella giustizia amministrativa, il panorama ordinamentale era ancora solidamente ancorato su basi di relativa certezza giuridica, quanto meno nei suoi principi di fondo. La strada intrapresa dai promotori di questo rinnovato percorso non era altro, in realtà, che un ritorno al passato, a quella cultura della giurisdizione che si era forgiata innanzitutto e specialmente nella magistratura ordinaria. Sembrava una strada tutto sommato percorribile con relativa facilità, in quanto coerente non solo con il disegno del Costituente repubblicano ma anche con l’essenza del mestiere di giudice, e non necessariamente vocata all’isolamento nella sua stessa terra di provenienza. E invece i fatti, spietatamente ancorati alla norma nuda e alle singole decisioni “di sistema”, hanno rivelato e stanno tuttora rivelando tutta la difficoltà di difendere posizioni di trincea che sembrano inesorabilmente destinate a divenire minoritarie, quanto meno nella percezione dell’opinione pubblica. Ma che cos’è il Giudice nella nostra attuale idea di democrazia? E’ ancora un soggetto inavvicinabile e privo di pregiudizi che rende giustizia affidandosi soltanto a soluzioni tecniche e di rigore applicativo della norma, o deve stare ben dentro la società e le Istituzioni per capirne a fondo le istanze, piegando, se necessario, l’interpretazione di fatti e diritto alla volontà del pensiero dominante o addirittura ai desideri della maggioranza politica di turno? E come si deve comportare concretamente questo Giudice in mezzo agli altri? Deve vivere in un eremo giudiziario e mantenere adeguato distacco dai protagonisti del potere esecutivo oppure mescolarsi con esso per conoscere a fondo i meccanismi operativi e “interni” delle amministrazioni e acquisire maggiore consapevolezza nelle decisioni, anche a rischio di far sbiadire la propria immagine di indipendenza ed autorevolezza? Resta poi da comprendere se il rapporto con gli altri attori fondamentali del processo, gli avvocati, debba essere improntato a un regime di cordiale ma netta distanza per evitare accuse di favoritismi o possa essere coltivato con disinvoltura al di fuori delle aule giudiziarie. Difficili domande per difficili risposte, in questi tempi incerti. E’ innegabile peraltro che in mezzo a una tale alternativa di scelte possano ergersi ad ago della bilancia proprio il cittadino e la sua percezione dell’amministrazione della giustizia: più disinformazione e rassegnazione all’inefficienza ci sono, maggiori saranno le possibilità che le differenze tra gli opposti comportamenti provochino una sostanziale indifferenza. Eppure una diversità ancora c’è, e riguarda non solo il modo in cui si mostra all’esterno il soggetto designato a giudicare ma anche gli effetti tangibili della eccessiva osmosi con ambienti che inevitabilmente potrebbero esercitare pressioni, indirettamente o direttamente, sulle scelte più delicate da assumere nelle aule di Tribunale. I promotori di questo sito avevano ben presente, nel dicembre del 2020, la difficoltà di coltivare un progetto di forte spinta verso i valori di terzietà del giudice anche nei meccanismi decisionali dell’autogoverno, in quanto tale progetto, pur in apparenza coerente con il sistema ordinamentale allora vigente nel nostro Paese, avrebbe potuto incontrare resistenze più o meno importanti in un apparato di giustizia, quello dei magistrati amministrativi, dove vi è un Giudice di appello, il Consiglio di Stato, che continua ad essere anche consulente del potere esecutivo. E fu questo dato a suggerire che la divulgazione scientifica e culturale desiderata fosse ancorata al primo grado di giudizio , in quanto terreno naturale dell’indipendenza e imparzialità rivendicate, specialmente per la marcata territorialità dei Giudici che ne fanno parte, e ancora di più per l’assenza in tale fase di collegamenti visibili con le Istituzioni “romane”. Il primo grado di giudizio è inoltre, e da sempre, lo snodo fondamentale dell’incontro tra i cittadini e la Giustizia, il momento in cui le contrapposte istanze difensive trovano una composizione molto spesso definitiva. E’ qui che il sistema ci mette la faccia in tutti i sensi, per la maggiore vicinanza tra fruitori del servizio e gestori della cosa pubblica. Ma è corretto parlare di primo grado di giudizio tout court , o non sarebbe forse meglio riferirsi ai “primi gradi” di giudizio? La giustizia, in Italia, pur avendo una matrice ideale unitaria, subisce declinazioni importanti a seconda dell’ambito a cui si riferisce. Si pensi alle differenze strutturali che corrono tra la giustizia civile e la giustizia penale e alle diverse esigenze che spingono il cittadino a ricorrere all’uno o all’altro rimedio. Senza considerare che all’interno dell’immenso calderone del contenzioso civile c’è di tutto, dalle eredità alle separazioni, passando per il diritto societario e per la tutela della proprietà, fino ad arrivare ai contratti di lavoro e alle questioni risarcitorie, patrimoniali e non. E tenendo presente che tra i protagonisti dei processi di prima istanza vi sono anche giudici non di carriera (come i giudici di pace) e i magistrati delle varie Procure della Repubblica sparse sul territorio nazionale, fino ad oggi selezionati con lo stesso concorso con cui sono scelti anche i giudici ordinari. Vi è poi la fitta costellazione dei giudici speciali , divisi principalmente tra giustizia amministrativa, giustizia tributaria e giustizia contabile, ognuna con il suo grado di importanza, in rapporto agli interessi tutelati, e il suo definito ambito di competenze. Soltanto la giustizia amministrativa, però, conosce un sotterraneo e pericoloso conflitto con il grado di giudizio successivo, ovvero l’appello. Si tratta infatti di un plesso giurisdizionale dove l’assenza sostanziale del terzo grado di giudizio e la divisione delle carriere – o divisione delle qualifiche che dir si voglia – ha portato a tutta una serie di effetti innaturali e distorti che si compongono in un precario equilibrio nell’Organo di autogoverno, salvo poi riemergere, di tanto in tanto, nello svolgimento della funzione giurisdizionale. E non vi è addetto al settore che non intraveda, dietro a pronunce del Consiglio di Stato [1] che provano ad estendere fortemente la possibilità di dichiarare la nullità delle sentenze emesse in prima istanza (con conseguente ritorno del processo al suo inizio), anche l’indiretta ricerca di una dinamica interna che inneschi una ripartizione “più equa” del carico di lavoro complessivo tra i due gradi di giudizio. Con inevitabili danni per il cittadino, però, che rischia di ritrovarsi punto e a capo dopo anni di causa e contro la sua stessa volontà, essendo pronto a rispettare nel merito la decisione presa, qualunque essa sia. E questo, vale la pena ricordarlo, proprio all’interno del sistema giurisdizionale che più di tutti sta dando prova di efficienza e celerità negli ultimi anni. D’altra parte, il primo grado non è una formula magica di giustizia giusta, ed è fisiologico che gli eventuali errori di giudizio vengano a mano a mano sanati negli altri gradi di giudizio. Né la velocità del risultato – sentenza in tempi record – può essere sempre sinonimo di qualità della decisione, potendo al contrario ingarbugliarsi ancora di più la vicenda giuridica all’esito di una pronuncia frettolosa e monca. Contemporaneamente, occorre fare molta attenzione a equiparare la riduzione dell’arretrato – che costituisce da sempre l’obiettivo storico della giustizia italiana – ad uno smaltimento di rifiuti indifferenziati , perché dietro ad ogni contenzioso, anche il più misero e apparentemente irrisolvibile, vi sono pezzi di vita vissuta o mancata, sacrifici, dolore e persone a cui appartengono quei sacrifici e quel dolore. E’ al contrario importante non creare nuovo arretrato, individuando correttamente i tempi di gestione di ogni processo prima ancora che se ne celebrino le singole udienze. D’altra parte, se nelle controversie individuali resta il titolare della posizione soggettiva ad essere parzialmente artefice della propria fortuna, tramite l’esatta comprensione della specifica chance di successo processuale a lui riservata e l’affidamento della difesa in giudizio, quando possibile, a un professionista adeguato, nei contenziosi in cui è un soggetto pubblico a rappresentare la collettività la bilancia della giustizia pende in modo diverso a seconda delle scelte di sistema del nostro Legislatore. In questo caso, il rimedio alle ingiustizie rese non è tanto un contenzioso “orizzontale” tra parti – che comunque tecnicamente rimane – quanto la volontà dello Stato di sanzionare illeciti che per la loro gravità vanno a colpire direttamente il cuore vitale della res publica , o determinando un vulnus macroscopico al rispetto della legalità tramite offese personali e patrimoniali (ad es. omicidi e furti, ma anche fatti di bancarotta fallimentare), oppure destabilizzando lo stesso sistema democratico (corruzione, abusi di potere e appropriazione di beni pubblici). Orbene, sotto quest’ultimo aspetto, secondo alcuni vi sarebbe stato negli ultimi anni un indebolimento della risposta normativa – e del conseguente apparato sanzionatorio – rispetto alle potenziali infedeltà degli amministratori pubblici. Dietro la lotta alla firmite e la dichiarata volontà di stabilire un principio di presunzione di buona fede in favore di chi gestisce il denaro della collettività, ci sarebbe in realtà, secondo i critici, un preciso progetto di smantellamento del sistema complessivo di vigilanza , derivato ideologico di un’ allergia culturale ai controlli. Prova ultima di ciò sarebbe la norma che ha recentemente rimodulato al ribasso il cosiddetto “ tetto alla responsabilità erariale ”. La disposizione in questione è contenuta nel disegno di legge che il 27 dicembre dell’anno appena trascorso è stato definitivamente approvato dal Senato della Repubblica, ovvero la cosiddetta “riforma della Corte dei Conti”, in cui sono contenute, da un lato, un pacchetto di modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 , dall’altro, la delega al Governo in materia di funzioni del massimo Organo costituzionale di controllo della contabilità pubblica, oltre che in materia di responsabilità amministrativa e di danno erariale [2] . Tra le modifiche immediatamente operative, già nei processi in corso, vi è quella che va a inserire il comma 1-octies nell’art. 1 della legge sulle disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti ; la novità normativa recita così: “ Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo (…) ”. Correlativamente, il nuovo comma 1-bis dell’art. 1 della L. n. 20/1994 , come modificato dalla disciplina appena approvata dal Parlamento, parla di “ obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo ”. Sembra dunque che da adesso in poi, nei giudizi di responsabilità intentati dalla Corte dei Conti – ovvero quei giudizi che mirano ad accertare responsabilità amministrative e/o contabili nella gestione della cosa pubblica – sarà impossibile recuperare, per compensare il danno erariale provocato, e salvo i casi di dolo o di illecito arricchimento, più del doppio dello stipendio annuale percepito dal responsabile. In altri termini, la dissennata o poco accorta condotta dei titolari degli organi di vertice, politici e amministrativi, di Stato, parastato, Regioni e Comuni – qualificabile comunemente e ordinariamente in termini di colpa grave – comporterà sempre e comunque che la maggior parte del danno subito dall’erario sia “spalmato” sulla collettività, con sottrazione diretta di risorse che potrebbero essere alla stessa destinate. Qualcuno ha beffardamente messo in parallelo la nuova norma sulla responsabilità erariale con la proposta di legge di riforma dei condomini presentata dalla maggioranza alla Camera, tramite cui si vorrebbe introdurre la possibilità per i creditori del condominio, in caso di debiti non pagati, di rivalersi in prima battuta su tutti i condòmini, e non solo su quelli morosi. Da un lato (responsabilità del condominio), la scarsa diligenza di alcuni si ripercuoterebbe negativamente su chi adempie puntualmente ai suoi obblighi, dall’altro (responsabilità erariale), l’inefficienza e l’imperizia degli amministratori pubblici si scaricherebbe quasi integralmente sulla collettività. Se a ciò si aggiungono le nuove norme che stabiliscono la presunzione di buona fede dei titolari degli organi politici i cui atti siano stati vistati dagli organi tecnici e la “stretta” sulla decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale (“dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno”, e indipendentemente da eventuali reticenze del responsabile), ecco allora che sembra portato a compimento il disegno di “alleggerimento” della responsabilità degli amministratori pubblici, cominciato qualche tempo fa con la soppressione del reato di abuso di ufficio. La domanda che però bisogna a questo punto inevitabilmente porsi è se il cambiamento di approccio culturale che è alla base di queste importanti modifiche normative sia giustificato da un reale miglioramento, in termini di preparazione e rettitudine, della nostra classe politica e dirigenziale. Siamo ancora il Paese degli sprechi pubblici e delle cattedrali nel deserto, delle tangenti e del clientelismo? Viviamo ancora, a certe latitudini, lo spettro delle mafie, e, a tutte le latitudini, quello delle loro ramificazioni? Questa è la domanda fondamentale a cui dare una risposta, prima di dare “fiducia” incondizionata agli amministratori pubblici, salvo poi punirli severamente dopo, quando i buoi sono ormai fuggiti dalle stalle. E resta qualche dubbio, in ogni caso, sul fatto che la fiducia possa al contrario essere “costruita” a priori con un sistema di deresponsabilizzazione sulle conseguenze di eventuali errori grossolani e superficialità nel maneggio del danaro pubblico, specie se poi, come spesso capita, non viene rispettato il principio di separazione tra funzione di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa. D’altra parte, l’indebolimento della risposta giudiziaria a fatti di mala gestio – che spesso e volentieri nascondono vere e proprie ruberie e corruttele – non può alfine che portare a un ulteriore scadimento dell’etica del cittadino medio, mentre le condotte illecite che ne conseguono rischiano di non essere più sanzionate nemmeno dinanzi al “mitico” Giudice terzo e imparziale, per il semplice motivo che questi non arriva a vederne più neanche una. [1] Cfr., tra le altre, Adunanza Plenaria n. 16 del 2024, Adunanza Plenaria n. 10 del 2025 e Consiglio di Stato, sent. n. 9734 del 2025 [2] https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01491492.pdf

Con pronuncia depositata il 20 giugno 2025 [1] , la Corte di Cassazione ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale, se risulti coerente con la disciplina eurounitaria la norma nazionale che consente di condurre nei centri in Albania cittadini stranieri destinatari di provvedimenti convalidati o prorogati, in assenza di qualunque predeterminata e individuabile prospettiva di rimpatrio. Dopo poco tempo, il 4 settembre 2025, la medesima Corte ha dichiarato non manifestamente infondata, così rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, la questione di legittimità della norma che permette, nei casi di trattenimento dello straniero nei centri istituiti in Albania, la permanenza in tali centri del richiedente asilo fino alla decisione sulla convalida del provvedimento del Questore che rinnova il trattenimento dopo la mancata convalida del primo atto di trattenimento [2] . Nel primo caso, sono state affrontate insieme, presentando profili di analogia, due vicende emblematiche della incapacità del nostro Paese di rimpatriare stranieri entrati nel territorio nazionale in condizioni di “clandestinità” maturate successivamente al loro ingresso da frontiere aeree. Due cittadini tunisini arrivati con visto turistico in Italia tra il 2020 e il 2021 avevano sostanzialmente eluso per anni la normativa in materia di immigrazione fino ad essere rintracciati ed espulsi “formalmente” nel 2025. L’espulsione non veniva tuttavia eseguita dalle autorità procedenti in quanto non vi era un aereo disponibile e gli interessati non avevano fornito un documento necessario a rimpatriarli; ne era conseguito il trasferimento e successivo trattenimento presso il Centro per i rimpatri di Bari. A quel punto, il Ministero dell'Interno aveva trasferito i cittadini tunisini al Centro per i rimpatri di Gjader, situato nel territorio della Repubblica di Albania e istituito in esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria . Avendo in tale luogo i due stranieri formulato richiesta di protezione internazionale per timore di persecuzione nel loro Paese di origine, il Questore di Roma aveva a sua volta disposto il trattenimento dei due cittadini tunisini presso il Centro di permanenza albanese, ai sensi dell' articolo 6, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 , secondo cui lo straniero deve rimanere nel Centro “anche” quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione. La Corte d'appello di Roma non ha però convalidato tale ultimo provvedimento, ritenendo che in pendenza dei termini ad impugnare l’eventuale diniego della Commissione territoriale deputata a decidere sull’istanza di protezione internazionale, e comunque in pendenza del relativo procedimento giurisdizionale, lo status di richiedente asilo è compatibile con quello di trattenuto , alle condizioni di legge, ma non con l'allontanamento dal territorio dello Stato , presso il quale egli ha il diritto di attendere la definizione del procedimento. In altri termini, secondo la Corte di Appello di Roma, lo straniero richiedente asilo avrebbe un diritto “perfetto” di restare sul territorio italiano, nell’attesa della definizione del procedimento amministrativo e giurisdizionale inerente alla protezione internazionale richiesta, e, conseguentemente, non potrebbe essere destinatario, nel frattempo, di un obbligo di trattenimento presso il Centro di Gjader, di per sé esterno ai confini nazionali. La Corte di Cassazione è stata a quel punto investita dell’affare dall’impugnazione da parte del Ministero dell’Interno del provvedimento di non convalida del trattenimento, e non ha potuto non notare la possibile incompatibilità tra le norme eurounitarie in materia e la disciplina interna che consente il trasferimento nel territorio di uno Stato non membro di migranti irregolari. Nel secondo caso (ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale), un cittadino senegalese, anch’egli trasferito nel Centro in Albania e anch’egli richiedente protezione internazionale, si era visto respingere dalla Commissione territoriale tale domanda, ed era stato contestualmente trattenuto al di fuori dal territorio nazionale tramite un provvedimento adottato dalla Questura di Roma ai sensi del già richiamato articolo 6, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142. A quel punto, non avendo la Corte di Appello convalidato il provvedimento questorile, il cittadino senegalese è stato di fatto trattenuto per un intero giorno – prima dell’intervento di un nuovo provvedimento di trattenimento adottato per profili di pericolosità sociale dall’autorità amministrativa competente – in assenza di un atto, di carattere provvisorio amministrativo, o di natura giurisdizionale, che fosse costitutivo di "titolo legittimante il trattenimento”. Ne risulterebbe così violato, secondo la Cassazione, l’ art. 13 della Costituzione , in base al quale, da un lato, è necessaria l’immediata liberazione di una persona non trattenuta legalmente, ovvero nel rispetto della procedura contenuta nello stesso art. 13 (provvedimento del giudice, o in via diretta o in sede di convalida di provvedimento amministrativo), dall'altro, la privazione della libertà personale non potrebbe essere disposta direttamente dalla legge. In entrambe le fattispecie, i Giudici di legittimità intravedono l'introduzione di un sistema di tutela dei diritti della persona quanto meno distonico rispetto all'architrave costituzionale e sovranazionale in cui tali diritti si inseriscono. Nel frattempo, e cambiando completamente prospettiva, mentre questi abitanti non particolarmente fortunati del nostro pianeta lottano con le unghie e con i denti per migliorare un po' la loro condizione personale di partenza, contando anche sulle civilissime regole di accoglienza del vecchio Continente, in Italia continua a trovare terreno fertile il doppio regime tra chi paga e chi non paga le tasse . Qui non vi è tanto materia di assenza di tutele, quanto di eccesso di tutele, seppure soltanto in una direzione. Secondo qualcuno, l’evasione fiscale non è più vissuta come un’emergenza nel nostro Paese, e forse non lo è mai stata, tanto che un dato di valore assoluto, rappresentato dal fatto che solo il 17,7 per cento dell’evasione scoperta è alla fine incassata, non suscita alcun dibattito. D’altra parte, secondo il comma 13 dell’art. 12-ter del d.l. n. 84 del 2025, convertito con modificazioni il 30 luglio ultimo scorso, il rinnovo, per gli anni 2025 e 2026, dell’ adesione al concordato preventivo biennale (ovvero l’accordo tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano determinati indici sintetici di affidabilità, per definire in anticipo il reddito imponibile su cui pagare le tasse per i successivi due anni) produce in favore di chi vi aderisce un condono tombale per le imposte sui redditi e l’Irap evasi negli anni tra il 2019 e il 2023. Cinque anni al prezzo di un unico versamento, si potrebbe dire. Se poi si pensa che la Corte dei Conti ha nelle scorse settimane stigmatizzato la nuova misura di rottamazione delle cartelle (siamo ormai alla “rottamazione quinquies”) – che secondo i Giudici contabili ridurrebbe la compliance fiscale e genererebbe il rischio che l’Erario diventi un finanziatore dei contribuenti morosi - si comprende il senso di ingiustizia che può diffondersi tra chi paga sempre e puntualmente - magari perché in parte costretto, come i dipendenti e i pensionati, che sono tassati alla fonte - ogni suo debito con lo Stato. Di certo, in giro per l’ordinamento italiano, esistono da un lato diritti un po’meno “perfetti” e tutelati di altri, qualora l’abuso di tali diritti non sia ontologicamente possibile, e dall’altro diritti rinforzati , qualora le regole possano essere più facilmente eluse. Il che è senz’altro un nostro peculiare paradosso. Quasi sempre può essere peraltro messa in discussione, con le più varie argomentazioni - tra cui le più risibili, sotto un profilo tecnico, sono quelle "da tifoso", o ideologiche che dir si voglia -, la correttezza delle informazioni su cui si basa l'analisi in questione. Si pensi alle diverse posizioni esistenti sulla magistratura . C'è una discreta fetta dell'opinione pubblica, oggi rinvigorita dal progetto costituzionale di separazione delle carriere, che dipinge i magistrati come categoria di soggetti privilegiati e intoccabil i, al di là dei demeriti e dei meriti dei singoli. Un esempio di ciò, secondo una parte della stampa, sarebbe la circostanza della "conservazione del posto" dei due pubblici ministeri di Milano De Pasquale e Spadaro, condannati in due gradi di giudizio a otto mesi per il reato di "rifiuto di ufficio". Secondo i Giudici che si sono finora occupati del caso, De Pasquale e Spadaro non hanno depositato, nel febbraio-marzo 2021, atti favorevoli, a loro segnalati dal Collega di Procura Paolo Storari, agli avvocati difensori nel c.d. processo Eni-Nigeria , processo per corruzione internazionale che, a sua volta, si è poi concluso con un'assoluzione piena e "corale" di tutti gli imputati. Questi magistrati godono dunque di una posizione privilegiata rispetto ai comuni mortali o invece le procedure di verifica in sede disciplinare di fatti gravi ma basati su ricostruzioni processuali e procedimentali complesse devono fare il loro corso senza pregiudizi aprioristici? È peraltro notizia certa che il CSM - ovvero il tribunalino dei Giudici - non è stato finora a guardare, avendo precluso nel frattempo a De Pasquale, proprio a seguito della vicenda del contestato rifiuto di ufficio, la possibilità di ottenere ulteriori incarichi direttivi. Occorre dunque sempre analizzare bene i fatti, prima di giungere a conclusioni, in merito all'eccesso di tutele, che potrebbero alla fine dei conti risultare affrettate. Sbirciando sotto altra prospettiva tra le pieghe della Giustizia nostrana, bisognerebbe anche capire se le vittime di favoritismi personali da parte dell'amministrazione pubblica - e ce ne sono tante, in giro per l'Italia - non abbiano ormai più alcuna tutela effettiva contro gli abusi che li hanno direttamente o indirettamente danneggiati, semplicemente perché con l' abrogazione del reato di abuso di ufficio sarà impossibile per i pubblici ministeri indagare sulle condotte illecite di favoritismo. Il campanello di allarme si è d'altra parte recentemente trasformato in una triste realtà nelle aule di giustizia, con riferimento alle accuse rivolte ai professori universitari accusati di avere "pilotato" le nomine agli ospedali fiorentini Careggi e Meyer. Tuttavia, la Corte costituzionale, sollecitata sul punto, ci ha spiegato che l’abrogazione del reato di abuso di ufficio da parte del legislatore italiano non contrasta con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, e che nessuno, neanche la stessa Corte, può sindacare la complessiva efficacia del sistema di prevenzione e contrasto alle condotte abusive dei pubblici agenti risultante da tale abrogazione, sovrapponendo la propria valutazione a quella del legislatore [3] . In altri termini, l'estensione della tutela, in questo caso, si amplia o si restringe a seconda di chi decidiamo di mandare in Parlamento. E se le persone soffrono e continueranno sempre a soffrire di scelte legislative e applicative che spesso introducono doppie velocità nell'ambito di un percorso - quello dei diritti assoluti - che dovrebbe essere teoricamente unitario e uguale per tutti, non se la passano meglio i nostri amici a quattro zampe , i quali, nonostante gli enormi progressi fatti negli ultimi anni per garantire loro maggiore tutela, continuano ad essere valutati alla stregua di una valigia, quando vengono smarriti in giro per gli aeroporti [4] . D'altra parte, nel nostro peculiare universo attuale, quando si misura il valore di qualcuno - uomo o animale che sia -, l'unica risposta che sembra avere vero peso è quella che fa riferimento alla sua importanza in termini economici, di potere o di influenza sui comportamenti sociali della massa. E solo qualche sparuto coraggioso individuo che ancora crede nella libertà di pensiero e nel dissenso ragionato, facendone derivare condotte coerenti nella vita di tutti i giorni, avrà l’ardire di rispondere, a fronte della tentata monetizzazione del suo impegno, che “ il punto non è questo ”. [1] Corte di Cassazione, Prima sezione penale, ordinanza del 19 maggio 2025, pubblicata il 20/6/2025, R.G.N. 14054/2025 [2] Corte di Cassazione, Prima sezione penale, ordinanza del 4 settembre 2025, pubblicata in pari data, R.G.N. 23258/2025 [3] Corte costituzionale, sentenza n. 95, depositata il 3 luglio 2025 [4] Corte di giustizia dell'Unione Europea, sentenza del 16 ottobre 2025 nella causa C-218/24, reperibile al seguente link: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=305206&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6931604

Quando, nell'ormai lontano 2004, chi vi scrive entrò in magistratura ordinaria, al Governo c'erano Silvio Berlusconi ed una maggioranza politica apertamente critica nei confronti del sistema giudiziario esistente. Era ormai passata l'epopea di Falcone e Borsellino - vittime di stragi mafiose ripugnanti che lo Stato non ha saputo prevenire -, ma ancor di più aveva ormai esaurito la sua spinta la controversa stagione di " Mani pulite ". La magistratura - specie quella penale - non era più considerata intoccabile , in quanto non godeva più dello stesso credito di dieci anni prima nell'opinione pubblica, e infatti fu "toccata" con la cosiddetta riforma Castelli . Pur con alcuni interventi probabilmente positivi su problemi reali (come l'introduzione della temporaneità delle funzioni direttive e la tipizzazione degli illeciti disciplinari), la prima vera riforma della magistratura ordinaria - in parte poi ritoccata dall'intervento della L. n. 111 del 2007 - , disancorando il passaggio agli incarichi di Presidente e Procuratore dalla regola della sola progressione per anzianità di servizio (cui conseguiva una semplice valutazione di "non demerito", ai fini dell'attribuzione delle funzioni) ha aperto le porte a un'estremizzazione del potere delle cosiddette correnti in seno al CSM. Dopo di che, gli accertati abusi correntizi sulle nomine hanno avviato un'ulteriore stretta nei confronti dei magistrati da parte della politica. Si potrebbe dire, con una sintesi estrema e forse un po'superficiale, ma non lontana da vero, che la riforma Castelli ha prodotto il fenomeno "Palamara" , e che il " caso Palamara ", aggravando una patologia già esistente, ha generato la necessità di operare nuovi interventi sul presunto malato grave, ovvero il sistema giudiziario nel suo complesso. Resta a questo punto da capire quanto il malato sia grave e quanto la medicina elaborata dall'attuale governo con il suo progetto di riforma della Costituzione sulla cosiddetta separazione delle carriere sia quella giusta e proporzionata rispetto al male da curare. Di certo, si è detto molto spesso, e non senza un minimo di ragione, che la magistratura abbia mostrato una certa incapacità di intervenire dal suo interno su alcune oggettive disfunzioni del sistema. La più grave incongruenza, a parere del sottoscritto, è stata l'estrema tolleranza nei confronti di un certo modo di fare il magistrato che, prima ancora che dannoso verso il sistema e verso la collettività, è stato percepito in modo critico e a tratti inaccettabile dalla classe forense, che pure spesso è restia, per comprensibili motivi, a denunciare la cosa alle Autorità competenti. L'arroganza, la superficialità di scrittura, la lentezza nelle decisioni e la maleducazione che in alcuni casi caratterizzano l'interpretazione del ruolo di giudice (ma lo stesso vale, mutatis mutandis , per i p.m.) meritavano e meriterebbero una presa di posizione molto severa da parte del CSM e, prima ancora, da parte dei capi degli uffici. E non può trovare facile compensazione nella pure indubbia elevata e generalizzata preparazione tecnica della categoria - scelta a seguito di uno dei concorsi più seri e qualificanti in circolazione -, caratteristica, questa, vieppiù esaltata dall'incomparabilità di spessore culturale specifico che esiste tra la magistratura togata e la magistratura onoraria, cui pure vanno a volte addebitate, per colpa del sistema di selezione di tale importante e rilevante categoria di ausilio giurisdizionale , pronunce che non fanno altro che appesantire il lavoro dei giudici togati di secondo grado e di quelli di legittimità. Correlativamente, un certo modo di fare giustizia di alcuni Procuratori della Repubblica - "condito" da smania di protagonismo e indagini apparentemente "mirate" - ha sempre più creato conflitti anche gravi nel tessuto interno degli Uffici, esponendo gli stessi a una facile critica e richiesta di "ordine" dall'esterno. D'altra parte, anche su questo aspetto la famosa riforma Castelli sembra avere fallito, producendo, con la semi-gerarchizzazione dell'ufficio del p.m., da un lato una eccessiva simbiosi tra Capo dell'ufficio e polizia giudiziaria, dall'altro una mortificazione dell'iniziativa del singolo magistrato. La riforma costituzionale della magistratura approvata appena due giorni fa al Senato senza alcuna modifica rispetto al testo originario presentato dal Governo [1] ha la peculiare caratteristica di non affrontare nessuno dei nodi problematici emersi nel tempo con riferimento all'efficienza ed efficacia del sistema Giustizia - che prima di ogni altra cosa dovrebbe assicurare qualità e velocità di risposta alle istanze dei cittadini, qualunque sia il tenore di tali istanze -, ma di provare a ridefinire il ruolo di giudici e pubblici ministeri, separandone irreversibilmente i percorsi professionali. In aggiunta, il Legislatore mostra notevole sfiducia nel sistema che fino ad oggi ha regolato l' autogoverno dei magistrati ordinari, sottraendo ai due nuovi CSM (quello dei giudici e quello dei p.m.) le decisioni in materia disciplinare - che saranno effettuate da un ulteriore organo appositamente istituito, l' Alta corte - e svuotando di fatto il potere delle correnti con l'introduzione del metodo del sorteggio "secco" per accedere ai Consigli, in luogo del metodo elettivo. Al di là della correttezza o meno dell'intervento di ortopedia istituzionale immaginato dall'attuale Governo in carica - e posto che la riforma è proposta in aperto contrasto con la volontà di molti dei soggetti nei cui confronti agirà, ovvero i magistrati -, il panorama sul cui sfondo si delinea tale riforma è tutt'altro che indicativo di uno scenario idilliaco, per quanto riguarda i rapporti tra politica e magistratura , il che, già di per sé, avrebbe dovuto forse consigliare maggiore prudenza nell'imporre un punto di vista sull'altro senza una vera mediazione sostenibile. Colpiscono in particolare alcune vicende di contrasto palese tra poteri dello Stato che si sono nel frattempo delineate. In primis , la questione della definizione di Paese sicuro e del contenzioso in merito alla titolarità o meno del singolo Governo di individuare in modo definitivo e non sindacabile dai giudici quali siano i Paesi sicuri, nonché la vicenda Open Arms , riaccesa dalla decisione della Procura della Repubblica di impugnare la sentenza di assoluzione emessa in favore di Matteo Salvini. [2] Secondariamente, due potenziali conflitti tra politica e magistratura non decisivi ma fortemente evocativi del clima che si respira, ovvero la vicenda del disegno di legge " Salva Milano " - portato avanti in aperto contrasto con le iniziative giudiziarie della magistratura meneghina, che sono recentemente sfociate anche in richieste di custodia cautelare in carcere - e la questione delle Olimpiadi invernali 2026 , con la denuncia da parte dei pubblici ministeri procedenti, secondo qualificate fonti di stampa, del tentativo di sterilizzazione di una loro indagine in materia di turbativa d'asta tramite la qualificazione, per decreto legge, della Fondazione Milano-Cortina come ente di diritto di privato, sottraendolo ai vincoli e alle conseguenze giuridiche (e penali) che deriverebbero dalla sua qualificazione come organismo di diritto pubblico. [3] Da ultimo, i magistrati hanno espresso al più alto livello netta contrarietà al c.d. decreto sicurezza , tramite la relazione su novità normativa dell' ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione , sia con riferimento al merito che con riferimento al metodo seguito nell'approvazione della nuova disciplina. Colpisce, in particolare, in quest'ultimo scatto critico sull'operato del Governo in carica, il chiaro riferimento ad una sostanziale sovversione della separazione procedurale stabilita dalla Costituzione tra esercizio ordinario del potere legislativo delle Camere ed esercizio straordinario di tale potere da parte dell'esecutivo, avendo il Governo di fatto esautorato , secondo la relazione, con un decreto legge, il Parlamento nel mentre questo svolgeva il suo compito istituzionale, e procedeva alla discussione in Senato, dopo la prima approvazione della Camera, delle medesime norme confluite poi nel decreto-legge, al fine neanche troppo velato di evitare ulteriori "perdite di tempo" con l'eventuale ritorno (in caso di modifiche) del testo alla Camera. Tutto questo cosa c'entra però con la separazione delle carriere e con l'elezione tramite sorteggio dei rappresentanti di giudici e pubblici ministeri? Si pensa forse che i conflitti con la politica diminuiranno di numero o si attenueranno nell'intensità? O che l'individuazione di una linea di confine netta tra le due categorie di giuristi indebolirà la capacità della magistratura - nella sua rappresentanza istituzionale e associativa - di costituire un argine "tecnico" rispetto agli abusi del potere politico? Perché la verità è che se la tesi di partenza è che l'ufficio del pubblico ministero si propone nel nostro Paese come un "potere irresponsabile", avendoglielo l'attuale assetto costituzionale consentito, allora sarebbe stato forse più coerente sottoporlo direttamente alla direzione funzionale dell'esecutivo, con tutte le conseguenze che ciò comporterebbe, tuttavia, in termini di minori garanzie del cittadino comune . Correlativamente, pare ormai spuntata la tesi secondo cui i giudici sarebbero succubi dei pubblici ministeri, avendo trovato tale tesi clamorosa smentita in un numero veramente importante di vicende giudiziarie note al pubblico, ed essendo al contrario ormai evidente, anche in alcuni risvolti processuali balzati recentemente sugli altari della cronaca, che il magistrato requirente medio non gradisce che il suo giudice venga meno, anche solo in apparenza, al requisito dell'imparzialità e indipendenza dalle parti coinvolte nel procedimento. [4] Piuttosto, dovrebbe forse preoccupare il Legislatore la possibilità che un Ufficio del p.m. sottratto dalla comune cultura della giurisdizione propria dei giudici - fino ad oggi garantita a tutti i magistrati dal concorso unico, dal tirocinio indifferenziato prima dell'assunzione delle funzioni e dalla possibilità di provare almeno una volta entrambe le esperienze professionali - potrebbe, questo sì, diventare graniticamente autoreferenziale e interessato soltanto a produrre numeri in positivo. E i numeri che contano, nel settore penale, non sono altro che arresti, sequestri e condanne. Con la prospettiva che più le decisioni si identificano con richieste e non con veri e propri giudizi e più nell'animo del singolo magistrato rischia di avviarsi un lento ma inesorabile processo di deresponsabilizzazione e impoverimento culturale. D'altra parte, se è vero che inquisire è diverso dal giudicare , è altresì vero che l'attuale maggioranza politica non è arrivata al punto di negare che entrambe le attività devono essere svolte con indipendenza . E allora, si è chiesto Ferruccio de Bortoli a margine di una lectio magistralis di Gustavo Zagrebelsky, " perché separare le carriere "? [5] Nell'occasione, l'ex presidente della Corte costituzionale ci ha ricordato la vera essenza del ruolo di chi svolge funzioni giurisdizionali (qualunque esse siano), ovvero l'interpretazione di tale ruolo con modestia e rigore . E se il motivo della riforma in corso di approvazione in Parlamento sta nel fatto che si crede che la somma delle singole indegnità abbia colpito irreversibilmente la credibilità dell'intero ordine, forse bisognerebbe agire a fondo sulle cause. Ma se non si crede questo, e l'unica necessità è contenere le (relativamente poche) mele marce , possibilmente cacciandole per sempre dalla magistratura, torna in mente la sproporzione tra la punizione e i demeriti denunciata nel film " Gli spietati " dallo sceriffo, mentre il fuorilegge gli punta il fucile sulla testa prima di sparare. [6] [1] Proposta di legge C. 1917 (Meloni, Nordio; S. 1353) "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare", approvata in prima lettura dalla Camera in data 16 gennaio 2025 e dal Senato in data 22 luglio 2025. [2] Si veda, per un approfondimento di entrambe le questioni, l'articolo pubblicato sul sito al seguente link: https://www.primogrado.com/i-migranti-della-discordia-viaggio-in-uno-scontro-tra-poteri-tipicamente-italico Nelle more, quanto alla definizione di Paese sicuro, è stata discussa la problematica giuridica di fondo dinanzi alla Corte di Giustizia UE (ma non è ancora stata depositata la relativa sentenza), dopo l'acquisizione del parere indipendente dell’Avvocato generale Richard de la Tour, che ha proposto alla Corte, tra l'altro, di pronunciarsi nel senso che non è contraria al diritto eurounitario una prassi in forza della quale uno Stato membro procede alla designazione di un Paese terzo come Paese di origine sicuro mediante atto legislativo, a condizione che il giudice nazionale investito del ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale proposta da un richiedente proveniente da un siffatto Paese disponga, in virtù dell’obbligo di un esame completo ed ex nunc imposto da detto articolo 46, paragrafo 3, delle fonti di informazione sulla cui base il legislatore nazionale ha inferito la sicurezza del paese interessato. [3] Per un approfondimento della vicenda delle Olimpiadi 2026 si rimanda al seguente link: https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/25_aprile_16/milano-cortina-2026-e-la-fondazione-pubblica-o-privata-i-pm-al-gip-manda-alla-corte-costituzionale-la-legge-meloni-oppure-37e8d020-9589-4b99-814e-f3d67b366xlk.shtml [4] Si veda al riguardo quanto riportato dal Corriere della Sera al seguente link: https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/25_giugno_16/caso-alessia-pifferi-il-pm-chiede-l-astensione-del-giudice-l-anm-di-cui-e-dirigente-critico-le-mie-indagini-547f7c66-e9f8-46a5-beab-af8eb701dxlk.shtml [5] L'articolo di de Bortoli è rinvenibile al seguente link: https://www.corriere.it/frammenti-ferruccio-de-bortoli/25_marzo_20/il-giudice-guido-galli-zagrebelsky-e-il-senso-della-giustizia-ac7e00cb-240f-42cb-ab81-3a49e66f5xlk.shtml [6] https://www.mymovies.it/film/1992/glispietati/
*Il riferimento alle riviste ha il solo scopo di segnalazione dei contenuti, e il lavoro dell'autore carattere meramente compilativo
Il Codice del Processo Amministrativo
Giustizia Amministrativa
Diritto e società

(dalle Spigolature filosofiche n. 39: La trasformazione del diritto internazionale secondo Carl Schmitt) PREMESSA (a cura di Roberto Lombardi) Le violazioni impunite del cosiddetto diritto internazionale spingono a chiederci, innanzitutto, quale sia oggi il valore di una categoria giuridica per certi versi "vuota", in quanto apparentemente priva della necessaria "cogenza". Certo, la circostanza che una regola non possa essere fatta valere in concreto non elimina in astratto il suo valore programmatico e di determinazione collettiva degli assetti soggettivi e oggettivi. Contemporaneamente, però, la sottrazione a priori della forza di coercizione , insita in ogni norma ordinamentale che si rispetti, spunta le armi di chi voglia affermare il principio sulla cui base si è fatto avanti o si è difeso. Quando in un'intervista con la Cnn, l’influente consigliere di Trump e vicecapo dello staff della Casa Bianca Stephen Miller, a proposito della minacciata annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti, ha affermato che « nel mondo reale vige la legge del più forte », ha detto una cosa che in tanti pensano, ma che nessun rappresentante dei cosiddetti Stati democratici ha il coraggio di pronunciare apertamente, un po' per le conseguenze di caos non controllabile che ne deriverebbero, un po'perché le regole potrebbero in ogni caso fare comodo, di tanto in tanto, al potente di turno. Se i principi su cui, ottant’anni fa, è stata fondata l’ Organizzazione delle Nazioni Unite , conservano ancora un valore - primo fra tutti il principio di autodeterminazione dei popoli - il recente attacco ad uno Stato sovrano con rapimento del suo Presidente e di sua moglie deve essere considerato un'aggressione unilaterale, come tale da condannarsi, al di là delle più o meno nobili motivazioni, con la stessa fermezza con cui vanno condannate tutte le violazioni del diritto internazionale, dall’invasione russa dell’Ucraina alle minacce di aggressione nei confronti di Taiwan. D'altra parte, ogni intervento militare esterno, motivato soltanto da interessi geopolitici ed economici, nel momento in cui viola la sovranità di uno Stato, viola altresì il diritto internazionale, e dovrebbe trovare una risposta in sanzioni adeguate, aprendosi altrimenti scenari di instabilità e violenza incontrollabile. Ma se poi anche i giudici dei Tribunali deputati a giudicare sui crimini di guerra sono minacciati nella loro integrità fisica e morale [1] , ecco che il diritto internazionale rischia di diventare una favoletta da raccontare ai più piccoli quando si parla dell'eterna lotta tra il bene e il male. Sempre che il bene e il male davvero abitino questo pianeta, e non sia vero invece, come dice Lord Voldemort , che esiste " solo il potere e chi è troppo debole per usarlo ". LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE (a cura di Sergio Conti) Gli eventi di questi ultimi giorni hanno reso di sempre maggiore attualità l'interrogativo, che riecheggia in questi mesi di continue violazioni dei principi del diritto internazionale, sull'effettività del medesimo o, addirittura sulla sua perdurante sussistenza. In tale contesto, mi pare utile richiamare le acute osservazioni di Carl Schmitt svolte nel saggio Die Wendung zum diskriminierenden Berlin 1938 ,“Il concetto discriminatorio di guerra” del 1938. Schmitt, nell'Introduzione a Die Wendung, afferma che " la storia del diritto internazionale è una storia del concetto di guerra " (p. 3) poiché è in esso che " si rispecchia il disordine dell'attuale situazione mondiale " (p. 3), in cui non è dato intravedere - al di là di una pretesa universalistica che distrugge Stati e popoli (p. 73) - un possibile 'ordinamento concreto' capace di colmare il vuoto lasciato dal tramonto di " una teoria ordinatrice del diritto internazionale forse debole ma sicuramente autentica ed efficace " (p. 73). Le linee fondamentali del pensiero dell'illustre studioso sono indicate nella recensione di Claudia Terranova pubblicata su Jura Gentium – Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale – nel 2009, in occasione dell'uscita della prima traduzione italiana dell'opera ( Il concetto discriminatorio di guerra , a cura di Stefano Pietropaoli, Prefazione di Danilo Zolo, Roma-Bari 2008). La recensione - rinvenibile online all'indirizzo: https://www.juragentium.org/books/it/wendung.htm - fornisce una efficace guida di lettura dei passaggi salienti e della tesi di fondo di Schmitt. Nel rinviare alla lettura integrale della stessa, si riportano qui di seguito alcuni passaggi cruciali: “(...) le pagine del saggio propongono, seppure abbozzate, delle tesi che sono di grande rilievo, poiché propongono non solo un'acuta interpretazione delle relazioni tra il vecchio 'occidente europeo' e il nuovo 'occidente americano', ma offrono una conferma sorprendente della 'profezia apocalittica' annunciata: "l'avvento di una guerra globale sottratta a ogni controllo e limitazione giuridica, ampiamente asimmetrica, nella quale una grande potenza neoimperiale si schiera non solo e non tanto contro singoli Stati, quanto contro organizzazioni di 'partigiani globali' (Kosmopartisanen) che operano su scala mondiale usando gli strumenti e perseguendo gli obiettivi di una guerra civile" (p. XXVIII). Non diversamente dagli scritti degli anni '50, in questo testo la critica schmittiana investe l' ideologia universalistica di impronta liberaldemocratica , quale fondamento teorico della Società delle Nazioni e denuncia il ricorso da parte di quest'ultima, alla "guerra giusta", inscindibilmente connessa alla discriminazione del nemico . Quel che in Die Wendung viene da Schmitt sottolineato con forza è che, nell'ambito di una visione universalistica, il confine tra ciò che è guerra e ciò che non lo è, diviene labile e illusorio generando "anarchia e caos" (p. 81) e spalancando l'abisso di una " guerra civile mondiale ". Non a caso, già nel '38, Schmitt si esprime così: "Oggi la questione quindi non è più se una guerra sia giusta o ingiusta, lecita o illecita, ma se sia realmente una guerra o non lo sia. Il grande contrasto 'planetario' fra i popoli è già così profondo da toccare i concetti più essenziali e porre il dilemma tra guerra e non guerra" (p. 65). Quali testimonianze "della nuova fase di sviluppo in cui è entrato il diritto internazionale del dopoguerra" (p. 5), Schmitt si impegna in una critica del "nuovo concetto internazionale di guerra" - critica che domina l'impianto teorico del saggio - e sostiene che la 'svolta' impressa al diritto internazionale da Woodrow Wilson è la chiave di lettura per comprendere la dissoluzione dello jus publicum europaeum . Se il 2 aprile 1917 - data dell'entrata in guerra degli Stati Uniti - rappresenta, per Schmitt, come sottolinea Zolo, " una data di eccezionale valore simbolico " (p. V), è perché essa inaugura nel diritto internazionale un nuovo orientamento di matrice universalistica. Questa nuova fase - dominata in realtà dal "progetto egemonico statunitense" (p. XI) - è, agli occhi di Schmitt, molto più che un semplice episodio degli eventi bellici, poiché consacra "la fine della centralità politica e giuridica dell'Europa" (p. VI). Le logiche della guerra "vecchio stile", basate sui concetti non discriminatori di guerra e di neutralità che avrebbero dovuto regolare e limitare le ostilità, cedono ora il passo ad un nuovo repertorio bellico, di ispirazione wilsoniana , in cui la guerra è tale solo se può definirsi giusta e addirittura umanitaria. Trasformatasi da "grande spazio" difensivo, territorialmente definito con la dottrina Monroe , in una linea di squalificazione morale del resto del mondo secondo l'interpretazione universalista e despazializzata di Wilson, la linea dell'emisfero occidentale impone adesso ovunque, come osserva Zolo, "il monopolio della sua economia, della sua visione del mondo, della sua interpretazione del diritto internazionale, del suo stesso linguaggio e vocabolario concettuale" (p. X). Ora che "la questione della guerra giusta è stata posta" (p. 61) e che la centralità dello Stato quale detentore dello jus ad bellum è stata rimossa, è opportuno chiedersi "se il nuovo concetto internazionale di guerra, che ha avuto origine nella Società delle Nazioni e nel Patto Kellogg, e che su questa base distingue tra guerra giusta e guerra ingiusta, [...] possa funzionare come elemento ordinatore" (p. 61). Il disordine in atto, contrassegnato da "numerose lotte sanguinose di fronte alle quali si evita prudentemente di usare il concetto di guerra" (p. 3), appare a Schmitt il segno inconfutabile che nessun ordine alternativo è seguito al dissolvimento dei vecchi ordinamenti. Un motivo in più per far luce sul nuovo concetto di guerra che, lungi dal rappresentare, per Schmitt, una semplice analisi di carattere teorico, aiuta tutt'al più, sul piano giuridico, "a disperdere la nebbia delle attuali ingannevoli finzioni e a mostrare la reale situazione del diritto internazionale odierno" (p. 3). Banditi i presupposti tradizionali della guerra en forme , si inaugura così, in nome di un principio universalistico-ideologico, con pretesa ecumenica, un nuovo tipo di guerra: la moderna guerra giusta totale . L'irruzione di una discriminazione nel diritto internazionale - risalente al trattato di Versailles del 1919 , nel quale si condanna come 'criminale' l'imperatore Guglielmo II e che Schmitt non si stanca di rievocare - non solo "priva del loro prestigio e della loro dignità i concetti di guerra e di nemico" (p. 68), ma annientandoli entrambi, riduce la guerra ad un'esecuzione o "azione di polizia" internazionale condotta legittimamente dalle 'forze del bene' contro i perturbatori della pace. Entro questo orizzonte manicheo che divide il mondo in buoni e cattivi, non c'è posto per la neutralità dei terzi che perde, così, ogni legittimità: "Non appena viene negata l'idea di una possibile neutralità e con essa la nozione di 'Stato terzo' non partecipante alle ostilità, emerge la pretesa di esercitare un dominio universale o regionale" (p. 65). Non c'è da stupirsi - insiste Schmitt - che nella guerra "discriminante" moderna, abbandonato il concetto di justus hostis , "capolavoro della ragione umana" insieme allo Stato, riemerga, quale nemico da annientare, il pirata , ovvero, "per evocare la versione moderno-metropolitana dei pirati, il gangster" (p. 72), che ai nostri giorni assume il volto del terrorista. La regressione del concetto giuridico di justus hostis a concetto teologico di nemico assoluto, trasforma il nemico in un mostro disumano che non va solo sconfitto ma annientato.” L'autore della recensione osserva conclusivamente (e si era nel 2009) che “ Non può sfuggire la scottante attualità di queste pagine, il cui valore profetico è sempre più confermato ed arricchito dagli avvenimenti della realtà odierna che, dalla guerra del Golfo alla guerra "umanitaria" fino alla guerra al terrorismo, segnano tragicamente la nostra epoca ”. Non resta che amaramente osservare come gli anni trascorsi e gli eventi disumani che li hanno caratterizzati ci dimostrano vieppiù la veridicità di tale tesi. [1] Si consulti al riguardo il seguente link: https://unipd-centrodirittiumani.it/it/notizie/corte-penale-internazionale-giudice-italiano-della-corte-condannato-in-contumacia-a-15-anni-di-reclusione-da-un-tribunale-di-mosca

Beni pubblici e servizi pubblici sono temi classici del diritto amministrativo. In queste brevi considerazioni, tuttavia, essi vengono in rilievo non già nella loro dimensione statica, e quindi in un’ottica sistematica; quanto piuttosto nella dinamicità della loro gestione, essenziale per garantire che l’azione amministrativa sia effettiva [1] . E in effetti, l’approccio del giurista allo studio dei beni e dei servizi pubblici è soggetto ad evoluzione, sia in ragione delle modifiche alla normativa applicabile, sia in correlazione all’affermarsi di nuove prospettive di esame nella dottrina economica [2] , sia, ancora, per l’emergere di nuovi interessi e valori nella società. I servizi pubblici sono paradigmatici di questa storia di evoluzione. Sul piano dell’azione amministrativa, l’assunzione diretta di quelli locali [3] da parte dei Comuni e delle Provincie, disposta dalla l. 29 marzo 1903, n. 103, che accordava prevalenza alla loro gestione in economia o alla creazione di aziende municipalizzate, ha lasciato il passo all’adozione di moduli privatistici, attraverso la creazione di strumenti societari o il ricorso a forme di partnerariato tra soggetti pubblici e privati . Inoltre, accanto alle società miste, si è via via sempre di più il modello, invero contemplato sin dalle origini, dell’esternalizzazione dei servizi attraverso l’istituto della concessione. Ciò è avvenuto in coerenza con i princìpi di apertura al mercato che animano il diritto europeo in ragione di un approccio liberista che ne costituisce il presupposto economico/ideologico, tanto da ritenere eccezionale il ricorso all’ in house providing . Per farvi ricorso è necessaria « una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando (…) i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi (…) » (art. 17 d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, in materia di servizi pubblici locali, cui si armonizza l’art. 7, comma 2 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36). La presa d’atto dei fallimenti del mercato, che ben possono esservi, ha posto più di recente l’accento sull’aspetto della regolazione dei servizi. Paradigmatica, in questo senso, è l’attribuzione ad ARERA di poteri regolatori in materia di ciclo dei rifiuti da parte dell’art. 1, commi 527 ss. l. 27 dicembre 2017, n. 205. L’evoluzione nella concezione dei beni pubblici è meno evidente. Innanzitutto, perché non si può tuttora prescindere dalle categorie fissate dal legislatore codicistico. Dunque, benché già il Giannini [4] nei primi anni ’60 del secolo scorso abbia teorizzato una diversa catalogazione dei beni pubblici (beni comuni, domìni collettivi, demani comunali), l’operatore giuridico continua a doversi confrontare con la tripartizione tra beni demaniali, beni del patrimonio indisponibile e del patrimonio disponibile. A tale inquadramento consegue lo statuto dei beni demaniali , cui vengono attribuite le caratteristiche, invero comuni ai beni del patrimonio indisponibile, dell’inalienabilità, della non espropriabilità, nonché della sottoposizione a un regime di protezione che contempla la possibilità di esercizio dell’autotutela esecutiva. Sono comunque da mettere in evidenza due aspetti. Da un lato, vi è la tendenza, che affonda le proprie radici nel quadro costituzionale, in cui è addirittura l’istituto della proprietà – un tempo sacro e inviolabile – a essere informato alla sua funzione sociale (art. 42 Cost.), a considerare maggiormente corretta una concezione oggettiva del bene pubblico, che è tale in quanto preordinato al soddisfacimento di interessi della comunità [5] . A ciò si riconnette il secondo aspetto, in realtà meritevole di maggiore approfondimento rispetto a quello che ha avuto, che è quello delle possibilità di accesso ai beni, sia nella prospettiva di un uso generale di questi, sia con riferimento alla possibilità di garantirne un uso particolare. La tendenza a concepire in senso oggettivo i beni pubblici si coglie in numerose manifestazioni. La più rilevante è l’affermazione della categoria dei beni comuni [6] , che ha il suo archetipo nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sulle valli da pesca della laguna di Venezia [7] . In quell’occasione, la Corte si è trovata a pronunciare sulla natura demaniale o meno delle valli da pesca, e cioè delle aree lagunari delimitate da argini, che le separano dalla laguna aperta, che vengono usate per la vallicoltura, una forma di itticoltura estensiva. I contendenti privati, che potevano vantare la disponibilità di tale aree da generazioni, non contestavano che esse rientrassero nella categoria descrittiva dei beni del demanio marittimo, ma evidenziavano che il carattere della demanialità non poteva essere ritenuto sussistente in ragione del disinteresse dello Stato che, dopo l’unificazione e nonostante l’entrata in vigore prima del codice civile del 1865, quindi del codice civile del 1942, giammai aveva adottato un atto accertativo della demanialità. L’occasione è stata colta dalla Corte Suprema per un’innovativa ricostruzione del sistema, che valorizza l’applicazione diretta degli artt. 2, 9 e 42 Cost. , ricavandone il principio della tutela della personalità umana e del suo corretto svolgimento, nell'ambito dello Stato sociale, anche nell'ambito del " paesaggio ". Quest’ultimo va visto con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativa-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della "proprietà" dello Stato, ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell'intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività. Da tale quadro normativo-costituzionale, e fermo restando il dato "essenziale" della centralità della persona , da rendere effettiva, oltre che con il riconoscimento di diritti inviolabili, anche mediante «adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», emerge l'esigenza interpretativa di "guardare" al tema dei beni pubblici oltre una visione prettamente patrimoniale-proprietaria per approdare ad una prospettiva personale-collettivistica . Ciò comporta che, in relazione al tema in esame, più che allo Stato-apparato , quale persona giuridica pubblica individualmente intesa, debba farsi riferimento allo Stato-collettività , quale ente esponenziale e rappresentativo degli interessi della cittadinanza (collettività) e quale ente preposto alla effettiva realizzazione di questi ultimi; in tal modo disquisire in termine di sola dicotomia beni pubblici (o demaniali)-privati significa, in modo parziale, limitarsi alla mera individuazione della titolarità dei beni, tralasciando l'ineludibile dato della classificazione degli stessi in virtù della relativa funzione e dei relativi interessi a tali beni collegati. Ne deriva quindi che, là dove un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato sociale come sopra delineato, detto bene è da ritenersi, al di fuori dell'ormai datata prospettiva del dominium romanistico e della proprietà codicistica, "comune" vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini. Del resto, la Corte di Cassazione ha rilevato come già da tempo, la dottrina ma anche la stessa giurisprudenza hanno fatta proprio l'idea di una necessaria funzionalità dei beni pubblici , con la conseguente convinzione che il bene è pubblico non tanto per la circostanza di rientrare in una delle astratte categorie del codice quanto piuttosto per essere tonte di un beneficio per la collettività, sino ad ipotizzare casi di gestione patrimoniale dei beni pubblici (come la loro alienazione e cartolarizzazione). Non è un caso, in quest’ottica, se anche il novero dei beni pubblici si amplia . Vi si debbono far rientrare, innanzitutto, le reti infrastrutturali [8] , che vanno intese non come semplice complesso di beni mobili o immobili, ma come l'insieme di infrastrutture fisiche e immateriali che supportano l'erogazione di servizi. Quindi, tra i beni pubblici si ricomprendono la rete di dispacciamento dell’energia elettrica (individuata con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 3, comma 7 d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79), la rete di distribuzione del gas (definita dall’art. 9 d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164), l’infrastruttura ferroviaria (d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112, allegato I). Ma tra i beni pubblici occorre inserire anche i beni culturali , ancorché appartenenti ai privati, giacché, una volta che ne sia stato dichiarato l’interesse culturale ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, essi sono sottoposti a un regime stringente di protezione (l’art. 20 del Codice pone il divieto di distruzione, deterioramento, danneggiamento) e di conservazione (art. 30, comma 3 ss. del Codice), con sottoposizione dell’alienazione a un regime di autorizzazione o di denuncia (art. 56 del Codice). Proprio alla ricostruzione in termini di oggettività del concetto di beni pubblici risponde anche la possibilità, appunto, che vi sia la dicotomia tra natura pubblica del bene e attribuzione a privati di diritti dominicali . D’altra parte, già con l’ art. 43, comma 2 l. 23 dicembre 1998, n. 448 , erano stati attribuiti in proprietà a un soggetto formalmente privato, Ferrovie dello Stato S.p.a., i beni immobili necessari all’esercizio del servizio ferroviario. Non diversa è la logica per cui la gestione del demanio sia attribuita a soggetti diversi da quelli titolari dei beni. È quanto è accaduto al demanio marittimo, allorché, con l’ art. 59 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la sua gestione, ma non la titolarità dei beni che lo compongono, è stata attribuita alle Regioni. La divaricazione è stata superata con gli artt. 3 e 5 d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85, che ha trasferito anche la titolarità del demanio marittimo alle Regioni, che però a loro volta (si vedano, ad esempio, l’art. 4 l.r. Veneto 4 novembre 2002, n. 33; l’art. 4 l.r. Calabria 21 dicembre 2005, n. 117; l’art. 6 l.r. Puglia 23 giugno 2006, n. 17) hanno delegato a livelli più basi della piramide amministrativa alcune funzioni di gestione del demanio marittimo. Rimane da fare un cenno, pur breve, al tema dell’ accesso ai beni pubblici , o forse sarebbe meglio dire della loro fruizione da parte della collettività [9] . In tal proposito, va ricordato il movimento che portò al referendum abrogativi del 12 e 13 giugno 2011, ove due quesiti abrogativi riguardavano l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economia e, soprattutto, la previsione della necessaria adeguata remunerazione del capitale privato investito nei servizi idrici integrati. Ritorna utile, inoltre, riferirsi a quell’ampia fetta di contenzioso amministrativo relativo alla possibilità di proroga generalizzate delle concessioni per finalità turistico-ricreative di porzioni del demanio marittimo, fluviale, lacustre. I temi che si agitano sono molti e ben noti: vanno dal potere di disapplicazione della normativa nazionale contrastante con il diritto europeo da parte delle amministrazioni pubbliche all’individuazione dell’ambito rilevante per la determinazione della natura, scarsa o meno, della “risorsa” di cui si tratta; dai criteri di affidamento delle concessioni al preteso diritto di indennizzo degli operatori per gli investimenti posti in essere. Scarsa riflessione, invece, vi è stata sull’incidenza delle proroghe automatiche nel tempo predisposte dal legislatore sull’accesso, sulla possibilità di fruizione, da parte della collettività, del bene demaniale marittimo. In realtà, la tutela dell’interesse degli operatori economici, diversi da quelli già concessionari, di ottenere un godimento particolare di una porzione del bene è adeguatamente tutelato dall’affermazione dell’assorbente principio di concorrenza . L’adozione di procedure competitive garantisce pari prospettive di accesso a un godimento riservato del bene pubblico da parte di tutti gli operatori economici interessati. La prospettiva della fruizione generalizzata del bene pubblico è, invece, sottovalutata. Infatti, le concessioni del demanio marittimo, fluviale o lacustre per finalità turistico-ricreative comportano necessariamente la privazione della generalità dei consociati dal godimento di quei beni assegnati in uso esclusivo, sacrificio a fronte del quale la mano pubblica ottiene il pagamento di un canone e altri benefici indiretti (traslazione sul concessionario degli oneri di custodia e manutenzione). Ebbene, una durata temporale via via crescente delle concessioni demaniali priva le amministrazioni della possibilità di rinnovare, di volta in volta, la valutazione sull’opportunità di sottrarre il bene demaniale alla fruizione collettiva; ovvero di adeguare le condizioni di esercizio imposte al concessionario alla misura del corrispettivo sacrificio imposto alla collettività; ovvero ancora di esplorare nuove tipologie di concessione del bene, che pongano in un punto diverso l’equilibrio tra l’interesse della collettività a fruire del bene pubblico e l’interesse degli operatori economici di ottenere, per finalità di lucro, lo sfruttamento esclusivo di quel bene. Si tratta di ricadute negative di non poco momento, su cui varrebbe la pena che il pensiero giuridico si soffermasse maggiormente, allorché si tratta di trovare un assetto ragionevole alla disciplina delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative. [1] L’attualità del tema dell’effettività dell’azione amministrativa emerge anche dal fatto che il Conseil d’État francese abbia dedicato lo studio annuale 2023 al tema L’usager du premier au dernier kilomètre de l’action publique: un enjeu d’efficacité et une exigence démocratique. [2] Si veda, a titolo di esempio, il recente studio dell’Eurispes su Immobili pubblici: Patrimonio da valorizzare (2025). [3] Per una ricostruzione più ampia dal punto di vista storico, si rinvia a M. Dugato, I Servizi pubblici locali (voce) in Enciclopedia del diritto – I Tematici III, Milano, 2022, pp. 1093-1100. [4] M.S. Giannini, I beni pubblici – Dispense delle lezioni del Corso di Diritto amministrativo tenute nell’anno accademico 1962-63, Roma, 1963. [5] Nell’ampia produzione, sia consentito di segnalare i due capisaldi, in chiave privatistica e in chiave pubblicistica, di un’alternativa lettura dei beni pubblici: P.Grossi, “Un altro modo di possedere”. L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria, Milano 1977; V. Cerulli Irelli, Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova, 1983. [6] Si veda F.Marinelli, Beni comuni (voce), in Enciclopedia del Diritto – Annali VII, Milano 2014, 157 ss. [7] Cass. Civ., Sez. Un., 14 febbraio 2011, n. 3655 [8] Si veda già F.Cintioli, Le reti come beni pubblici e la gestione dei servizi, in Dir amm., 2007, 293 ss. [9] Si veda S.Rodotà, Beni comuni. Una strategia globale contro lo human divide. Postfazione a M.R.Marella, Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Bologna, 2012
Sistema giustizia

E’ stato in via definitiva approvato al Senato il disegno di legge costituzionale, a firma del(la) Presidente del Consiglio e del ministro della Giustizia, riguardante “ Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte Disciplinare… ” che prevede: 1) la c.d. “separazione delle carriere” tra magistrati giudicanti e requirenti; 2) l’istituzione di due CSM (rispettivamente per i magistrati requirenti e i giudicanti) ; 3) un’ Alta Corte Disciplinare. Poiché la legge non è stata approvata a maggioranza dei due terzi del Parlamento, occorrerà attendere tre mesi per l’eventuale (molto probabile) referendum “confermativo” o “oppositivo” (se ne dà opposta definizione a seconda che a qualificarlo sia la maggioranza parlamentare che ha scritto la riforma o la minoranza che l’ha contrastata), privo comunque di quorum (la circostanza avrà effetti sul risultato referendario). Separazione delle carriere. L’ art 104 della Costituzione , che stabiliva che “la magistratura costituisce un (unico) ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere” è stato integrato con la dicitura “ ed è composto dalla carriera giudicante e da quella requirente ”. Non è azzardato sostenere che, più che la separazione delle carriere, è stata di fatto introdotta la separazione della magistratura, considerato che al posto dell’unico CSM vengono previsti due CSM: uno relativo ai magistrati giudicanti e l’altro ai magistrati requirenti, che avranno concorsi di accesso diversi, carriere diverse e in nessun modo intercambiabili, valutazione professionali diverse. Insomma, la Magistratura è stata di fatto scissa in due: Magistratura giudicante, con un proprio CSM e Magistratura requirente, con un proprio CSM. Rimane da chiedersi le ragioni che hanno portato a questa modifica costituzionale la quale sempre, e di sicuro questa volta, come è stato autorevolmente scritto, ha l’obiettivo di mutare gli equilibri istituzionali in favore di un potere a scapito di un altro. La Corte Costituzionale , nel giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum popolare sull’abrogazione di alcune disposizioni o parti di disposizioni dell’Ordinamento giudiziario in tema di passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o da queste a quelle, con la sentenza n. 37 del 2000 (in senso conforme la sentenza n. 58 del 2022) si esprimeva nei termini dell’ammissibilità giacché “ la Costituzione, pur considerando la Magistratura un unico Ordine, soggetto ai poteri dell’unico CSM, non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di un’unica carriera o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti o requirenti, o che impedisca limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dall’una all’altra funzione ”. Secondo i supremi giudici, dunque, nulla impediva che si potesse limitare o condizionare il passaggio dei magistrati da una funzione all’altra oppure dare luogo a carriere separate, purché all’interno dell’unità della Magistratura governata da un unico CSM. Coerentemente al sopradescritto dictum , con la legge Cartabia del 2022 (che ha portato a estreme conseguenze la legge Castelli del 2006) si sceglieva così di dettagliare le forme e i tempi del mutamento delle funzioni, e cioè del passaggio dei magistrati dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti o da quest’ultime alle prime. Si è così previsto che il magistrato che esercita la funzione requirente oppure quella giudicante può cambiarla in quella diversa una sola volta nel corso dei primi dieci anni della sua carriera ma alla condizione tassativa di traslocare in altra sede territoriale (ad es. dalla Lombardia al Piemonte o alla Liguria o ad altra regione; v ’è da dire incidentalmente come i passaggi di funzione interessino attualmente in via residuale meno del 4% dei magistrati e cioè 30/40 su un organico di circa 10.000). Magistrati distinti solo per funzione, giudicante e requirente, dunque, tutti e due governati dall’unico CSM. Senonché tale indicazione del supremo giudice si è voluta abbandonare in favore di una modifica della normativa costituzionale, il cui punto nevralgico è l’istituzione di un ulteriore, distinto (da quello dei magistrati giudicanti) CSM, chiamato a governare la diversa posizione e carriera dei PM. Nella lettura propagandistica che se ne fa, tale revisione costituzionale avrebbe la finalità di evitare la confusione e commistione dei ruoli tra magistrati requirenti e giudicanti, a garanzia - si dice - del diritto dell’imputato a essere giudicato da un magistrato organicamente diverso da quello che lo ha investigato ed accusato. Tale asserita preoccupazione in realtà non ha motivo di essere solo che si ponga mente al fatto che a legislazione vigente nell’ambito del processo l’imputato non corre in nessun momento il rischio di vedere il suo inquisitore (magistrato inquirente) sedere nel banco di chi successivamente sia chiamato ad esprimersi nei suoi confronti in termini di colpevolezza o innocenza (magistrato giudicante). Ma, si obietta da parte dei nuovi legislatori, la separazione delle carriere ( rectius : della Magistratura ) è imposta o comunque deriva o comunque è una conseguenza del riformato (con Legge costituzionale 23.11.1999, n. 2) art 111 della Costituzione che, come è noto, stabilisce che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo , nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. Il giudice terzo, secondo tale lettura della norma costituzionale, non può che essere un giudice separato anche da un punto di vista per così dire ordinamentale dal PM, un giudice che dunque sia inquadrato in un CSM diverso dall’altro, destinato a governare la carriera del magistrato inquirente, giacché solo con tale separazione si evita il rischio (o addirittura l’evenienza) che la collocazione comune nella stessa struttura giurisdizionale produca risultati decisori condizionati (a favore dell’accusa, si dice maliziosamente, sebbene solo a fior di labbra ). Orbene, non c’è dubbio che esistano ordinamenti giuridici in cui il magistrato giudicante anche sul piano della sua collocazione ordinamentale è distinto da quello requirente (e forse dovrebbe meglio dirsi inquirente). Ma non esiste un modello unico di PM e contano le tradizioni giuridiche diverse dei vari paesi. La nostra costituzione, caduto il fascismo e nata la Repubblica, ha deliberatamente scelto l’ unità della magistratura , formata da giudicanti ed inquirenti, con un unico CSM che ne tutela indistintamente l’indipendenza esterna da altri poteri. E dunque, a legislazione vigente, la terzietà del giudicante rispetto al requirente (il primo distinto dal secondo in ragione delle diverse funzioni in quel momento esercitate), indica solamente quella che è stata definita in maniera pertinente la sua neutralità processuale (meglio: neutralità nel processo ). Sulla indipendenza e neutralità del giudice, Carlo Mezzanotte in un libro a più voci (“ Magistratura, CSM e principi costituzionali ”) non a caso scriveva “..il giudice deve essere indipendente proprio nella misura in cui la funzione a cui è chiamato deve essere oggettiva e neutrale, e viceversa se la funzione del giudice perde oggettività e neutralità…..resta incerto il fondamento giustificativo" (della indipendenza). Tale neutralità indica quindi esclusivamente la necessità che il giudicante, nel decidere una questione sottoposta per la prima volta alla sua attenzione, con una postura neutrale (cioè indifferente agli interessi in causa e non pregiudicata – in applicazione del regime tassativo ed insuperabile delle incompatibilità - da precedenti sue prese di posizioni sulla medesima res judicanda ), deve scrupolosamente osservare le regole che presidiano il processo in modo da indirizzarlo verso l’esito di una corretta (ma, ove non accada, contrastabile attraverso i mezzi ordinari di impugnazione) ed imparziale (in modo assoluto) applicazione del diritto al caso in oggetto. La neutralità di cui qui si discute si può definire nei termini di un vero e proprio percorso processuale che si snoda attraverso le varie stazioni che via via presidiano l’ effettivo contraddittorio paritario tra le parti , la cui violazione comporta la nullità dell’atto e/o la inutilizzabilità della prova. Tale percorso approda da ultimo a una decisione che, sulla base del materiale probatorio legittimamente raccolto, motivi esplicitamente, tramite argomentazioni convincenti e soprattutto aderenti alla realtà dei fatti emersi in causa, le ragioni poste alla base del giudizio di colpevolezza o di innocenza. Questo è ciò che ci si aspetta dal giudizio, che sia l’esito di una verifica imparziale delle ragioni delle parti, non altro, certamente non che il giudicante sia necessariamente terzo in sede ordinamentale, materia indifferente alle aspettative del giudicando. Insomma, non è l’appartenenza alla stessa carriera dei magistrati requirenti e giudicanti ciò che è in discussione, non il (pre)giudizio che deriverebbe all’imputato dall’appartenenza (vicinanza: secondo gli interessati detrattori) del suo giudice allo stessa carriera di chi lo ha inquisito. Questa sospettata vicinanza è meno che un’opinione, è solo un’ inutile ed infondata maldicenza, smentita, oltre che da ragioni deontologiche afferenti al dovere di integrità e lealtà di chi è preposto alla funzione giudicante, dalla realtà dei fatti, che vedono percentuali pressoché equivalenti del numero delle sentenze di condanna (semplificando: che vedono accolte le richieste dei PM) e di quelle di assoluzione (con la stessa semplificazione: che rigettano le richieste di condanna dei PM). Per non dire che, a seguire tale logica, si imporrebbe che i giudici di primo grado appartengano ad una struttura ordinamentale diversa da quelli dei giudici dell’impugnazione e quest’ultimi ad un’altra diversa dai giudici di legittimità; tutti, anche nella riforma in oggetto, invece inalterabilmente stretti in una immodificata (almeno fino ad ora) colleganza. Istituzione di due CSM. Ma se l’attuale quadro normativo già prevede la distinzione dei magistrati per funzione e non vi sono elementi sistematici per ritenere obbligata la strada della separazione anche ordinamentale delle carriere, perché mai è stato istituito un secondo CSM riguardante quella, che sarà del tutto diversa, dei magistrati inquirenti? E, soprattutto, quali le conseguenze di tale modifica costituzionale? Intanto il magistrato inquirente, voluto e configurato dal costituente con le stesse garanzie di indipendenza dei giudici, viene sottratto alla comune cultura della giurisdizione , che non è una “vuota astrazione”, ma una delle ragioni (di certo la principale, data la natura di parte pubblica imparziale vincolata solamente alla legge, all’osservanza della quale egli “veglia” come “alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello stato, delle persone giuridiche e degli incapaci”) che gli impongono, nell’investigare, di “svolge(re) altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini” (è l’ art 358 c.p.p. che, nel disciplinare l’attività di indagine del PM, gli impone anche quest’obbligo investigativo) e, all’esito del processo, ove verifichi l’assenza di prove a carico dell’imputato, di chiederne l’assoluzione. Il sopracitato art 358 c.p.p. in effetti non è stato modificato o abrogato, ma è facile prevedere che chi ne lamenta oggi la sostanziale disapplicazione (ingiustamente, occorre dire, ove si considerino tutte le numerosissime volte in cui il PM chiede l’archiviazione della posizione dell’indagato) si troverà nella condizione di vedere realizzato, a riforma costituzionale eventualmente confermata dal referendum, per davvero il tono marcatamente e unidirezionalmente inquisitorio delle investigazioni. Insomma l’eterogenesi dei fini: un Pm oggi accusato di avere troppi poteri declinati in senso accusatorio che ne assommerebbe, nella sua solitudine ordinamentale, tutti gli altri derivanti da una funzione inevitabilmente destinata ad essere esercitata con l’obiettivo prevalente della condanna dell’imputato (l’abito fa sempre il monaco e quello che vestirà il nuovo PM sarà del tutto diverso da quello finora indossato). Ma l’esondare di un tale potere solitario, sottratto alla contaminazione derivante dalla comune cultura giurisdizionale che fino ad oggi lo caratterizzava, non è sostenibile da quella parte del potere politico già oggi incline a contestarne l’eccedenza, cosicché è inevitabile che esso sia destinato ad essere fortemente imbrigliato (non a caso l’attuale Ministro della Giustizia così si è espresso: “la riforma fa recuperare alla politica il suo primato costituzionale”). E la strada che si riesce ad intravvedere in favore di tale reclamato recupero della primazia della politica (che vi sono fondati timori che possa essere percorsa in modo squilibrato) è quella che porta al drastico ridimensionamento dei poteri del PM attraverso la sua sottoposizione al potere esecutivo. Il ministro della Giustizia non per caso ha detto: “ Il PM deve essere garante della legalità delle indagini della polizia giudiziaria, come accade in Gran Bretagna, dove è nata la democrazia ”. La conseguenza logica (comunque lasciata intravvedere come direzione di marcia) di tale asserzione è quella sopra paventata, giacché le indagini in tale prospettiva non le dirigerebbe più il PM (secondo quanto attualmente recita l’ art 327 c.p.p. , che può però essere modificato con legge solo ordinaria) ma la polizia, con il risultato che alla stessa potranno essere dati ordini esecutivi di muoversi in una direzione investigativa piuttosto che nell’altra, come pure di astenersi da indagini che si vuole che non si compiano. Il PM mero garante della legalità delle indagini di polizia diverrebbe una figura evanescente, direttamente condizionata da un organo sulla cui autonoma individuazione della “notitia criminis” come pure sulle successive investigazioni egli non ha potere o quantomeno poteri residui. Insomma, lo scenario alternativo che si prospetta è: a) un PM autoreferenziale dotato di fortissimi poteri e sempre più curvato, in ragione della sua solitaria collocazione e della dismessa comune cultura giurisdizionale, verso investigazioni finalizzate alla condanna dell’indagato/imputato; b) un PM esautorato dei suoi poteri di iniziativa investigativa e disciplinante solamente il traffico della polizia giudiziaria, di cui è facile prevedere l’eterodirezione. Comunque li si consideri, esiti non solo assai insoddisfacenti ma allarmanti per lo squilibrio dei poteri che la Costituzione repubblicana volle invece assolutamente equilibrati. Si può, in definitiva, dire che la magistratura nel suo complesso ne esce assai indebolita quanto a autonomia e indipendenza. Ed infatti, oltre al vulnus prodotto in sé e per sé dalla creazione di un CSM dei PM separato da quello dei Giudici, si è scelta, ad aggravare irreparabilmente il quadro, la strada di sorteggiare i magistrati che di tali organi di autogoverno faranno parte nella quota prevista. Si è insomma sottratto ai magistrati inquirenti e giudicanti il potere di scegliere i propri rappresentanti presso l’organo di autogoverno (qualcosa di inaudito: un organo costituzionale in cui l’elettorato attivo non può scegliere l’elettorato passivo! ), con la conseguenza che sarà il caso (parola terribile ) a determinarne la composizione. E ciò, peraltro, mentre i laici che faranno parte dei due CSM, espressi dal mondo politico, saranno sì anch’essi sorteggiati ma all’interno di elenchi preventivamente compilati (senza potersi escludere che siano aggiustati) dal Parlamento stesso (teoricamente nel numero esattamente corrispondente a quanti - e quali - dovranno essere eletti). La giustificazione per il sorteggio “puro” previsto, come si è detto, per i magistrati sarebbe la necessità di debellare le “correnti” che attraversano il CSM. Le stesse, contro una vulgata corrente che ne ha sottolineato solamente le pratiche lottizzatorie - che ci sono state e che vanno decisamente condannate -, hanno contribuito nel corso dei decennio ad un ampio dibattito sull’organizzazione (più o meno verticistica; più o meno aderente al principio del giudice naturale precostituito secondo criteri oggettivi non manipolabili dai vertici dell’ufficio; più o meno intransigente nella difesa dell’indipendenza esterna dell’istituzione e di quella interna dei singoli magistrati, ecc.) degli uffici giudiziari e su tutti i complessi temi della giurisdizione. Il sorteggio in ogni caso, a tutto concedere, non eliminerà che interessi opachi della stessa natura di quelli oggi giustamente stigmatizzati - in primis le nomine talora spartitorie alle cariche dirigenziali degli uffici giudiziari - possono coagularsi intorno ai nuovi centri di potere, e questa volta in modo che si può temere addirittura ancor meno trasparente perché fondati esclusivamente su prossimità strettamente personali, al di fuori di qualsiasi dibattito ideale, quale è quello che ha animato ed attraversato nobilmente il CSM fin dal suo insediamento. ALTA CORTE DISCIPLINARE. I due CSM sono spogliati dell’attribuzione disciplinare che viene, ex novo , assegnata all’Alta Corte Disciplinare, un organo estraneo all’organizzazione, composta da 15 giudici: a) sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettiva categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità; b) tre professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati di indicazione parlamentare estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso di tali requisiti ; c) tre nominati dal Presidente della Repubblica tra quelli aventi i requisiti sub b). Il presidente di tale Alta Corte Disciplinare viene eletto tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione soltanto dinanzi alla stessa Corte senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. E dunque, la materia disciplinare viene attribuita a un organo estraneo all’organizzazione giudiziaria, come se quest’ultima non fosse in grado di esercitarla, come avviene nelle altre magistrature (amministrativa, contabile, militare) così come nella PA e in tutti gli ordinamenti professionali. E ciò nonostante la Corte Costituzione con la sent. n. 100 del 1981 , pur respingendo l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 18 del r.d.l 31.5.1946, n. 511 (responsabilità disciplinare dei magistrati) avanzata con ordinanze dalla sezione disciplinare del CSM, abbia avuto a precisare che l’applicazione delle sanzioni disciplinari, volte ad assicurare il regolare svolgimento della funzione giudiziaria, non va ricercata, come per gli impiegati pubblici, nel rapporto di supremazia speciale della pubblica amministrazione verso i propri dipendenti, essendo fondata direttamente sulla legge E dunque l’istituzione della nuova autorità disciplinare fuori del perimetro giurisdizionale finisce oggettivamente per snaturarne la natura. L’obiettivo non è chiaro, un indizio potendo ricavarsi dalla circostanza che i magistrati che ne faranno parte dovranno essere sorteggiati a sorte da quelli che svolgano o abbiano svolto funzione di legittimità (“cassazionisti”), quasi a ribaltare il principio secondo cui i magistrati si distinguono solo per funzioni e non per collocazione gerarchica. Ma la norma che lascia addirittura basiti è quella relativa alla circostanza che contro le sentenze emesse dalla Corte Disciplinare in prima istanza si potrà fare appello solo alla stessa Corte, pur senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a deliberare la decisione impugnata. Si sarebbe così inteso escludere il ricorso alla Corte di Cassazione, che invece deve potere essere percorribile giacché non è stato modificato l’ art 111 della Cost. nella parte in cui assume che contro le sentenze (e quelle dell’Alta Corte sono sentenze) è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Altri sostengono che il ricorso potrà svolgersi solo nei limiti e con i limiti inerenti alla giurisdizione, come per le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti. Insomma, come è stato scritto, anche la riforma disciplinare, espressione, in uno con le altre modifiche sopra descritte, di una ingiustificata (ma che si comprende benissimo, solo che si considerino i ripetuti attacchi proveniente da una precisa parte politica) volontà punitiva nei confronti della magistratura, produrrà “ più incertezze di quanti nodi problematici, veri o presunti, saprà sciogliere ”.

PREMESSA Prima della disciplina organica stabilita dal d.lgs. n. 45 del 2024 , il collocamento fuori ruolo dei magistrati (in particolare, di quelli ordinari) era disciplinato in maniera non sistematica dall’ art. 50 d.lgs n. 160/2006 e dalla legge n. 190/2012 . Più in generale, la fonte normativa primaria del collocamento fuori ruolo dei pubblici dipendenti è costituita dall’ art. 58 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ; tale norma, in forza della disposizione di cui all’ art. 276, comma 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , era estensibile anche ai magistrati appartenenti all’ordine giudiziario. Di fatto, alcuni incarichi extragiudiziari, per il tipo di impegno che richiedono, presuppongono che il magistrato sia collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. L’istituto del collocamento fuori ruolo prevede che il magistrato chiamato a esercitare funzioni ontologicamente diverse dalle attribuzioni proprie della qualifica giudiziaria si distacca dalla struttura istituzionale d’origine e, pur conservando lo status di cui godeva presso l’amministrazione di appartenenza, lascia vacante l’ufficio del quale era titolare, che può essere assegnato, così, a un altro magistrato. Si tratta in altri termini di una modifica oggettiva e temporanea del rapporto di lavoro , per effetto della quale il dipendente viene destinato a svolgere, presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza, compiti speciali che presentano un qualche interesse (anche) per l’amministrazione originaria, senza recidere con quest’ultima ogni rapporto. Vi sono sempre stati, d’altra parte, molteplici discussioni in merito all’opportunità del collocamento fuori ruolo dei magistrati, in quanto le critiche rivolte a tale istituto sono essenzialmente tre: - l’amministrazione della giustizia non ne trarrebbe in concreto alcun vantaggio; - la destinazione ad altri incarichi avrebbe conseguenze negative in termini di organico e di sottrazione di energie lavorative agli uffici giudiziari; - una prolungata assenza dai ruoli potrebbe determinare una diminuzione del sapere professionale, con ricadute negative sul sistema giustizia al momento del ritorno alla giurisdizione. Si è, per altro verso, e in senso contrario, ritenuto che i magistrati fuori ruolo costituiscano una risorsa indispensabile e strategica sia per il miglioramento dell’efficienza di importanti settori dell’amministrazione sia per l'accrescimento del prestigio che la magistratura nel suo complesso riceve per la qualità dell’opera che la professionalità dei magistrati sa rendere anche al di fuori dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. Sotto questo profilo, il problema sarebbe consistito, più che altro, nell’introdurre o rendere più efficaci, nella normativa primaria e secondaria, alcuni principi di fondo volti a contemperare le esigenze delle amministrazioni “di destinazione” con quelle dell’amministrazione giudiziaria. E’ stato evidenziato, a tale riguardo, che le norme introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 avevano lasciano insoddisfatte alcune esigenze avvertite dalla magistratura come necessarie per la razionalizzazione del sistema, con particolare riferimento all’accesso agli incarichi, alla durata degli stessi, alla valutazione dell’attività prestata fuori ruolo e alla disciplina del rientro in ruolo. LA DISCIPLINA DEI FUORI RUOLO NELL’AMBITO DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA L’ art. 1, comma 1 della L. n. 71 del 2022 ha delegato Il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario. Tra le materie da modificare, nel rispetto dei criteri direttivi previsti dalla stessa legge delega, vi era anche il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili . Il Governo, nell’attuare tale delega, avrebbe dovuto individuare, tra l’altro, le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitare esclusivamente con contestuale collocamento fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, rispettare il principio secondo cui condizione dell'incarico da conferire è che lo stesso corrisponda a un interesse dell'amministrazione di appartenenza e prevedere la necessità di valutare sempre puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento dell'incarico fuori ruolo potrebbe determinare sotto i profili dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato. Sono stati poi previsti limiti di rilevanza e di tempo degli incarichi, con possibilità di individuazione di tassative deroghe, oltre che la necessità di individuazione della soglia di scopertura di organico della sede di servizio del magistrato oltre la quale non può essere autorizzato il fuori ruolo e la necessità di riduzione del numero massimo di fuori ruolo autorizzabili, con previsione della “ possibilità di collocamento fuori ruolo dei magistrati per la sola copertura di incarichi rispetto ai quali risultino necessari un elevato grado di preparazione in materie giuridiche o l'esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giudiziaria o una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria ”. La delega è stata infine attuata, seppure tardivamente rispetto al limite temporale stabilito per legge, dal d.lgs. n. 45 del 2024 . Facendo un passo indietro, per ciò che concerne la magistratura amministrativa , e prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, vi era una delibera interna del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa ( delibera del 10 maggio 2013 ) che, nel richiamare la normativa all’epoca vigente, distingueva tra fuori ruolo obbligatorio senza limiti, fuori ruolo obbligatorio con limiti e collocamento in fuori ruolo facoltativo . Con riferimento a quest’ultimo tipo di fuori ruolo, lo stesso veniva disposto in “ conseguenza della ritenuta impossibilità o inopportunità del contemporaneo svolgimento delle funzioni istituzionali e dell’incarico extra-istituzionale ”. Il totale dei magistrati collocati fuori ruolo non poteva superare, nel vecchio regime, il numero massimo di 26 (dal 2026 tale numero scenderà a 25), ad eccezione dei fuori ruolo obbligatorio “senza limiti” (a titolo esemplificativo: Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Sottosegretario di Stato, Giudice costituzionale), i quali dovevano sempre essere autorizzati, con eventuale contestuale rientro in ruolo dei fuori ruolo facoltativi e via via, secondo specifici criteri, dei fuori ruolo meno “vincolati” e vincolanti. La nuova disciplina ha di fatto posto il problema dell’abrogazione implicita della delibera interna che si era data l’organo di autogoverno in materia, ed è stata allo scopo designata una Commissione speciale che possa riordinare – specie nei punti in cui vengono affidate all’organo di autogoverno alcune scelte strategiche (ad esempio, individuazione della scopertura di organico degli Uffici oltre il quale non è consentibile il collocamento in fuori ruolo) – la cornice normativa applicabile ai magistrati amministrativi. Pare in ogni caso vincolante, rispetto a ogni altra "indicazione interna", la volontà del legislatore, espressa all' art. 2 del d.lgs. n. 45 del 2024 , secondo cui il magistrato deve sempre essere collocato in fuori ruolo, qualora l'incarico da svolgere presso altro ente pubblico non garantisca " l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario ". Nel frattempo, è prevalsa nel tempo l’interpretazione secondo cui anche i “fuori ruolo” possono essere autorizzati per lo svolgimento di ulteriori incarichi extraistituzionali, entro i limiti di cui all’ art. 4 comma 3, lett. h) della delibera del 18 dicembre 2001 del Consiglio di Presidenza (preesistenza di un incarico continuativo presso l’amministrazione interessata all’incarico stesso o presso altra amministrazione, qualora, nel secondo caso, il magistrato abbia in corso di svolgimento anche un altro incarico non continuativo). E anche il limite originariamente stabilito dalla delibera in materia di autorizzazione di incarichi di Presidente di collegio consultivo tecnico (secondo cui il magistrato fuori ruolo o in aspettativa non poteva assumere tale incarico) è stato rimosso dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 19 dicembre 2024. I CASI PIU’ RILEVANTI TRATTATI DAL CPGA DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE NORME Pur nell’assenza perdurante della nuova disciplina interna imposta dal d.lgs. n. 45 del 2025, e dopo l’entrata in vigore di tale decreto legislativo, il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa si è trovato ad affrontare, negli ultimi mesi, alcune delicate questioni sistematiche afferenti a richieste di collocamento in fuori ruolo (o di prosecuzione dello status di fuori ruolo presso la stessa o presso altra amministrazione). Si sono presentate, in particolare, cinque particolari situazioni rispetto alle quali il Consiglio ha dovuto riflettere a fondo sulla valutazione puntuale da effettuare, anche alla luce delle nuove norme. In un primo caso, un magistrato amministrativo in servizio presso il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano – Ufficio già gravato dalla presenza di tre giudici con sgravio di 2/3 in quanto componenti dell’organo di autogoverno – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere in fuori ruolo l’incarico di coordinatore del Gruppo di Lavoro sulla digitalizzazione dei contratti pubblici (Gruppo DIGIT) istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel dibattito che si è svolto in Plenum da un lato è stata fatta rilevare l’esplicita richiesta di fuori ruolo avanzata con missiva dal Ministro competente, dall’altro si è evidenziata la rilevante scopertura di organico del Tribunale di appartenenza. In particolare, è stato fatto notare che il d.lgs. n. 45 del 2024, all’ art. 6, comma 1 , ponga una condizione ostativa oggettiva e assoluta al collocamento fuori ruolo (“ Non può essere collocato fuori ruolo il magistrato la cui sede di servizio presenti un rilevante indice di scopertura dell'organico stabilita in via generale dall'organo di governo autonomo ”) e che il fatto che il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa non avesse ancora stabilito tale indice di scopertura non avrebbe dovuto esimere il Consiglio stesso ad esercitare una discrezionalità conferita per legge. Ciò, anche in considerazione del fatto che, quasi contestualmente, l’Organo di autogoverno in parola aveva adottato una delibera che aveva fissato alcuni criteri per lo svolgimento dell’incarico di componente della Commissione di concorso per magistrato tributario, prevedendo in tale ambito che l’esonero totale dal carico di lavoro, previsto dalla norma di legge, non potesse essere consentito ai magistrati che prestassero servizio in Tribunali qualificati come “sedi PNRR”, ovvero in Tribunali in cui altri colleghi hanno già uno sgravio del carico di lavoro per lo svolgimento di incarichi interni, ovvero ancora in Uffici con un indice di scopertura del 20%. In senso contrario, è stato opinato che, in assenza della determinazione da parte dell’organo di autogoverno della percentuale di indice di scopertura “ostativa”, gli unici elementi da prendere in considerazione fossero le eventuali ricadute negative che il collocamento fuori ruolo della richiedente avrebbero avuto sull’organizzazione e la funzionalità del T.A.R. Milano, ricadute negative che peraltro erano state escluse dallo stesso Presidente dell’Ufficio giudiziario interessato. E’ stato inoltre fatto notare che una richiesta basata sul rapporto fiduciario (tra Ministro e magistrato) fosse sufficiente a giustificare tanto l’incarico quanto la richiesta di fuori ruolo e che l’ art. 6, comma 3 stabilisce, in deroga alla regola dell’ ostatività di un “rilevante indice di scopertura”, che l'organo di governo autonomo “ può sempre valutare, tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza e dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, la possibilità di concedere il collocamento fuori ruolo in ragione del rilievo costituzionale dell'organo conferente (…) ”. Il conferimento in fuori ruolo è stato infine concesso con deliberazione a maggioranza; da notare che trattasi di ipotesi che le nuove norme collocano – in termini di resistenza e priorità – al gradino più basso ( lett. g), comma 1 dell’art. 7 del d.lgs.n. 45 del 2024 : “altri incarichi”). Un secondo caso ha riguardato la richiesta di un Consigliere di Stato ad essere autorizzato allo svolgimento dell’incarico di assistente di studio di uno dei Giudici costituzionali, con servizio a tempo pieno, dopo averlo svolto fino a quel momento a tempo parziale. In questo caso, la scopertura organica del Consiglio di Stato, pari al 13 per cento al momento della deliberazione, non sarebbe risultata ostativa, e l’unico rilievo di interesse sarebbe stata l’individuazione dell’orizzonte temporale entro cui autorizzare la durata del fuori ruolo. Sotto questo profilo, vi era un potenziale disallineamento tra le nuove norme introdotte dal d.lgs. n. 45 del 2024 (che nulla prevedono sulla necessità di rientro in servizio entro un determinato arco temporale) e la vigente disciplina interna, che consente in questi casi il collocamento fuori ruolo del magistrato per un massimo di tre anni, con obbligo del rientro e successiva permanenza in ruolo per almeno un biennio con effettivo esercizio delle funzioni di istituto ( articolo 4, comma 2, lettera a) della delibera C.P.G.A. del 10 maggio 2013 ). Il Plenum ha deciso di ritenere ancora applicabile la normativa interna vigente – in attesa di una modifica di essa da parte dell’istituita Commissione speciale - e ha dunque concesso all’unanimità il fuori ruolo, limitandolo ad una durata “iniziale” di tre anni. Il terzo caso “particolare” ha riguardato una Consigliera di Stato – transitata dai TAR nelle more dello svolgimento dell’incarico – che ha fatto istanza di rinnovo dell’incarico di Direttore del Servizio giuridico dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. La vicenda è stata caratterizzata dal succedersi di richieste tra di loro non coerenti: prima, di autorizzazione con fuori ruolo, poi, di autorizzazione ad un incarico di consulenza di contenuto analogo a quello dell'iniziale richiesta con rientro in ruolo, infine ancora – ma stavolta sulla base di diversa disciplina giuridica – domanda di prosecuzione dello stesso incarico già svolto, e ancora una volta in fuori ruolo. Mancava in particolare, con riferimento alla prima istanza, il parere obbligatorio prescritto dall’ art. 9, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 45 del 2024 ; nella fattispecie concreta, essendo il magistrato richiedente transitato dai TAR al Consiglio di Stato in posizione di fuori ruolo, tale parere avrebbe dovuto essere rilasciato dal Presidente del Consiglio di Stato stesso, in assenza di assegnazione formale della Giudice ad una Sezione. Inizialmente, il Consiglio di Presidenza ha autorizzato la prosecuzione dell’incarico, prevedendo contestualmente il rientro in ruolo della richiedente, e respingendo la tesi secondo cui, trattandosi di incarico rientrante tra quelli presupponenti il “fuori ruolo obbligatorio”, secondo la Tabella B della delibera del 10 maggio 2023, punto b), fosse da ritenersi incompatibile con lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali la prosecuzione del lavoro di Direttore del Servizio giuridico dell’Autorithy . Tale orientamento si era in effetti consolidato in passato proprio con riferimento al medesimo incarico svolto dalla richiedente, e non sarebbe stato scalfito, secondo questa tesi, dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 45 del 2024, il cui articolo 16 del decreto, nello stabilire la linea di compatibilità tra la disciplina precedente e quella attuale, lascia espressamente in vigore l’ art. 1, comma 66 della legge Severino , sulla cui base è fondata la Tabella “B” sopra citata. D’altra parte, anche qualora non si fosse voluta applicare la norma sull’obbligo di fuori ruolo, vi sarebbe stato pur sempre l’ articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 45 del 2024 , il quale stabilisce che: " Tutti gli incarichi presso Enti pubblici o Pubbliche Amministrazioni la cui assunzione non può garantire l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario possono essere svolti nel rispetto delle previsioni del presente decreto soltanto a seguito del collocamento fuori ruolo o nei casi specificamente previsti dalla legge del collocamento in aspettativa ", dovendosi probabilmente dubitare che la tipologia di incarico ricoperto dalla richiedente non avesse carattere assorbente sotto il profilo del tempo impiegato nello svolgimento di esso. Successivamente al rilascio di tale autorizzazione, peraltro, una nota del Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva investito nuovamente della questione l’Organo di autogoverno, affinché lo stesso riesaminasse la deliberazione assunta in punto di rientro in ruolo della Consigliera di Stato, sulla base della legge istitutiva dell’Authority, secondo cui sarebbe stato possibile avvalersi di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche per svolgere incarichi di tipo dirigenziale, qualora non fosse possibile reperire al proprio interno professionalità dotate delle necessarie competenze, come nel caso in esame, ma soltanto se tali dipendenti “esterni” risultassero “collocati in posizione di fuori ruolo” nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Il Consiglio di Presidenza ha a questo punto accolto l’istanza di riesame così avanzata, non prima però di acquisire il parere del Presidente titolare della Sezione del Consiglio di Stato a cui nel frattempo la richiedente era stata formalmente assegnata. Tale parere non era né positivo né negativo, limitandosi il Presidente in questione a sottolineare che era stato talmente poco il tempo di rientro in servizio del magistrato alla sua Sezione assegnato da rendere impossibile l’individuazione in concreto dell’eventuale pregiudizio eventualmente derivante dalla nuova vacanza di organico. D’altra parte, erano nel frattempo pervenute due note da una rappresentanza sindacale del personale impiegato presso l’A.G.C.O.M., che denunciavano una situazione di disagio asseritamente occasionata da comportamenti del magistrato svolgente l’incarico di Direttore di Servizio. Su questo fronte, mentre la maggioranza del Consiglio ha ritenuto di non poter attribuire rilievo a tali segnalazioni, in quanto il loro contenuto non atterrebbe ai profili alla cui verifica è chiamato il Consiglio di Presidenza, una tesi dissenziente ha rimarcato che le evidenziate problematiche di carattere lavorativo e relazionale potrebbero suggerire una potenziale incompatibilità inerente alla permanenza del magistrato nell’amministrazione di destinazione, e che, anche alla luce della normativa interna in materia di autorizzazioni agli incarichi, avrebbe dovuto essere necessaria una valutazione in concreto, al fine di porsi, prima di autorizzare l’incarico, il problema della lesione del prestigio non solo del plesso, ma anche del magistrato stesso, nel caso in cui fossero infondate le accuse implicitamente contenute nella lettera del sindacato. D’altra parte, il comma 4 dell’art. del d.lgs. n. 24 del 2024 stabilisce che “ in ogni caso l'organo di governo autonomo deve valutare le ricadute provenienti dallo svolgimento dell'incarico fuori ruolo sotto il profilo della possibile lesione della immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio delle magistrature ”. L'autorizzazione alla "ripresa" dello svolgimento dell'incarico in posizione di fuori ruolo è stata infine concessa, seppure a maggioranza. Un'ulteriore fattispecie ha riguardato il caso di un magistrato TAR che ha partecipato ad una selezione pubblica in seno al Consiglio di Europa per assurgere al compito di legal advisor del GRECO, organismo internazionale che si occupa di contrasto alla corruzione – tramite monitoraggio del rispetto da parte degli Stati aderenti di determinati standard in materia - e che è stato istituito dallo stesso Consiglio di Europa. Il magistrato richiedente ha evidenziato l' interesse dell'amministrazione a consentirgli un incarico ritenuto prestigioso e di sicura attinenza con materie interferenti anche con il diritto amministrativo (in considerazione della trasversalità della materia “corruzione”), mentre il Capo dell'Ufficio dove egli presta servizio, nel rendere il richiamato parere di cui all'art. 9, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 45 del 2024, ha evidenziato che il venir meno del suo Collega avrebbe determinato una scopertura di organico molto rilevante (circa il 30%) e si sarebbe posto in contrasto con la necessità, a carico dell'interessato, di recuperare l'arretrato individuale di lavoro accumulatosi per via della fruizione di alcuni congedi parentali “frazionati”. Quanto al primo aspetto, è stato peraltro fatto rilevare che la norma di riferimento del d.lgs. n. 45 del 2024 a cui "appoggiare" la richiesta di fuori ruolo fosse l' art. 5, comma 5 e non l'a rt. 11, comma 3 , posto che l'incarico da ricoprire era di esperto amministrativo (incarico non riservato a magistrati) e non afferiva direttamente all'esercizio di funzioni giurisdizionali. D’altra parte, mentre l’art. 5, comma 5 dispone che “ L'interesse dell'amministrazione è sempre sussistente per gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati, per gli incarichi presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, per gli incarichi apicali, anche di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri o per incarichi presso organismi dell'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte”, il comma 6 dello stesso articolo dispone che “L'interesse dell'amministrazione di appartenenza non si ritiene sussistente quando l'incarico non richieda un elevato grado di preparazione in materie giuridiche ovvero una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria o esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, giudiziaria, consultiva o di controllo ”. Quanto al secondo aspetto, la natura non vincolante, rispetto alla decisione del Consiglio, del parere del Capo dell'ufficio, non eliminava il dato oggettivo di una rilevantissima scopertura dell'organico di tale Ufficio, una volta che fosse stato autorizzato il fuori ruolo. L'organo di autogoverno ha dapprima respinto, a voto segreto, la proposta della Commissioni congiunte di accogliere la richiesta autorizzazione in fuori ruolo. Tuttavia, una volta emesso il preavviso di diniego ed esaminate le osservazioni dell'interessato, lo stesso Consiglio è tornato sui suoi passi, e ha infine concesso il fuori ruolo, nonostante alcuni Consiglieri abbiano fatto notare la contraddittorietà interna della decisione, non essendo emerso alcun elemento di fatto nuovo rispetto a quelli già presi in considerazione nell'esprimere il primo voto sfavorevole. Altro caso di rilievo affrontato dall'organo di autogoverno dei magistrati amministrativi nel presente anno è quello di un magistrato Tar che dopo vari anni in fuori ruolo presso il Garante della Privacy è stato proposto e nominato dal Ministro della difesa in qualità di Segretario generale del suo Ministero. La peculiarità di questa fattispecie sta nella assenza di soluzione di continuità tra le attività prestate al di fuori dei ranghi giurisdizionali da parte del magistrato interessato, con conseguente "costruzione" di una sorta di carriera parallela rispetto a quella di Giudice, carriera che pare implicitamente osteggiata dalle nuove norme, in teoria più restrittive della disciplina anteriormente vigente. Tuttavia, in presenza di una serie di eccezioni continue alla regola - così come contenute nel testo del d.lgs. n. 45 del 2024 - e in assenza di obblighi espliciti di rientro dal precedente incarico, prima di assumerne uno diverso, il Consiglio ha anche in questo caso autorizzato la permanenza di fuori ruolo, con un solo voto contrario.